 Possiamo immaginare un futuro scintillante di un mondo appena oltre il presente in cui la carne è abbondante e accessibile, con quasi nessun costo per l’ambiente e senza la preoccupazione esistenziale legata all’uccisione degli animali. Al centro di questa visione ci sono mega-strutture high-tech, che ospitano serbatoi d’acciaio (i bioreattori o fermentatori) alti come palazzi contenenti migliaia di litri di terreni di coltura cellulare ed in grado di produrre milioni di chili di carne, tali da nutrire un intero paese. È una visione edonistica, ma anche altruistica, una scappatoia per gli eccessi dell’umanità, perché consente di risparmiare acqua, liberare terreni, proteggere le specie vulnerabili e la biodiversità e ridurre le emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale. Parliamo di carne coltivata o carne a base cellulare, correlata all’origine biologica delle cellule e al metodo di produzione, impropriamente chiamata carne sintetica o artificiale, termini imprecisi che possono avere una connotazione negativa per i consumatori. L’aspetto semantico con l’utilizzo di una terminologia per i nuovi alimenti prodotti utilizzando nuove tecnologie – più facilmente comprensibile dal grande pubblico – è rilevante per superare la potenziale neofobia e la possibile riluttanza verso le nuove scelte alimentari. Esistono diverse definizioni di carne coltivata. Quella che preferisco è la seguente: la carne coltivata è una carne animale genuina, in grado di replicare le stesse proprietà sensoriali e nutrizionali di quella convenzionale, in quanto costituita dello stesso tipo di cellule organizzate nella stessa struttura dimensionale del tessuto muscolare animale. In parole povere, la carne coltivata è prodotta a partire da vere cellule animali, ad esempio cellule prelevate da un bovino, un pollo, un suino, un pesce. L’unica differenza è che il prodotto è sempre basato su cellule animali ma non siamo costretti ad allevare e macellare animali.
Possiamo immaginare un futuro scintillante di un mondo appena oltre il presente in cui la carne è abbondante e accessibile, con quasi nessun costo per l’ambiente e senza la preoccupazione esistenziale legata all’uccisione degli animali. Al centro di questa visione ci sono mega-strutture high-tech, che ospitano serbatoi d’acciaio (i bioreattori o fermentatori) alti come palazzi contenenti migliaia di litri di terreni di coltura cellulare ed in grado di produrre milioni di chili di carne, tali da nutrire un intero paese. È una visione edonistica, ma anche altruistica, una scappatoia per gli eccessi dell’umanità, perché consente di risparmiare acqua, liberare terreni, proteggere le specie vulnerabili e la biodiversità e ridurre le emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale. Parliamo di carne coltivata o carne a base cellulare, correlata all’origine biologica delle cellule e al metodo di produzione, impropriamente chiamata carne sintetica o artificiale, termini imprecisi che possono avere una connotazione negativa per i consumatori. L’aspetto semantico con l’utilizzo di una terminologia per i nuovi alimenti prodotti utilizzando nuove tecnologie – più facilmente comprensibile dal grande pubblico – è rilevante per superare la potenziale neofobia e la possibile riluttanza verso le nuove scelte alimentari. Esistono diverse definizioni di carne coltivata. Quella che preferisco è la seguente: la carne coltivata è una carne animale genuina, in grado di replicare le stesse proprietà sensoriali e nutrizionali di quella convenzionale, in quanto costituita dello stesso tipo di cellule organizzate nella stessa struttura dimensionale del tessuto muscolare animale. In parole povere, la carne coltivata è prodotta a partire da vere cellule animali, ad esempio cellule prelevate da un bovino, un pollo, un suino, un pesce. L’unica differenza è che il prodotto è sempre basato su cellule animali ma non siamo costretti ad allevare e macellare animali.
Sebbene di recente interesse, l’idea originale di carne coltivata ha radici antiche. Nel 1923, JBS Haldane nel libro ‘Dedalo della scienza e del futuro’ prospettò l’idea del cibo sintetico o coltivato in laboratorio. Winston Churchill nel 1931, critico nei confronti dei metodi di allevamento, introdusse l’argomento della carne coltivata. Ma la prima ricerca di carne coltivata risale al 2002, quando la NASA pubblicò uno studio sulle colture di cellule muscolari di tacchino e filetto di pesce rosso. A seguire nel 2013 Mark Post, uno scienziato olandese presentò il primo prototipo di carne a base di cellule di muscolo scheletrico bovino, sotto forma di hamburger, costato circa 290 mila euro per 142 grammi. Ma il vero pioniere della carne coltivata è l’olandese Willem van Eelen, che negli anni 80’ pose le basi per questa nuova tecnologia. Oggi il testimone di Willem van Eelen è passato a sua figlia Ira van Eelen, cofondatrice di RespectFarm, un progetto pilota che in alternativa ai grossi impianti, propone il decentramento della produzione di carne coltivata, riadattando le infrastrutture agricole esistenti in strutture per la carne coltivata e garantendo la transizione dei mezzi di sostentamento degli agricoltori verso un modello di business più sostenibile. RespectFarm fa parte del programma di ricerca collaborativo FEASTS per la carne e pesce coltivato, finanziato con fondi strutturali e di investimento europei, e propone l’integrazione dell’agricoltura tradizionale con l’agricoltura cellulare, con un ruolo futuro nel passaggio verso la sostenibilità. Negli ultimi dieci anni, dunque il concetto di agricoltura cellulare, in particolare la coltivazione di carne e frutti di mare da cellule animali, è passato dalla fantascienza al mondo reale, sebbene con un mercato di nicchia, in alcuni paesi.
Ma come si produce la carne coltivata? Sinteticamente si parte dal prelievo di cellule (per lo più staminali perché dotate di estesa capacità rigenerativa) da un animale tramite una biopsia, e loro inserimento in un bioreattore (o fermentatore), che riproduce le stesse condizioni che le cellule incontrerebbero all’interno del corpo, tra cui presenza di sostanze nutritive, ossigeno e fattori necessari per la crescita e differenziazione. In alternativa alla biopsia che necessita di prelievi continui, non garantisce l’uniformità dei campioni e presenta limiti dovuti alla soglia di divisione delle cellule primarie (limite di Hayflick), si possono utilizzare linee cellulari più omogenee e performanti e conservate in biobanche. La carne coltivata rappresenta dunque una fusione di biologia e tecnologia, afferisce alla agricoltura cellulare che unisce la tecnologia delle colture cellulari e biologia delle cellule staminali (in prestito dal settore biofarmaceutico) alla ingegneria tissutale-cellulare del settore della medicina umana rigenerativa.
Su questo sfondo di innovazione tecnologica una domanda ricorrente è questa: ma è naturale? Una riflessione che discende da un mito sociale più ampio secondo cui naturale equivale a migliore, più sano e più sicuro. Siamo avvezzi a romanticizzare il naturale e questa preferenza deriva da pregiudizi radicati legati ad un comfort psicologico: la naturalezza sembra familiare e sicura, anche quando la scienza suggerisce il contrario. E su questo c’è un forte influenza del marketing. Etichette come biologico o naturale sono progettate per rassicurarci, ma possono oscurare i costi ambientali ed etici della produzione. E’ una prima impressione che però si scontra con una realtà molto più complessa. Sappiamo che gli alimenti naturali o convenzionali sono spesso imprevedibili. Prendiamo ad esempio la carne tradizionale prodotta in ambienti (allevamenti ed impianti di macellazione e lavorazione) in cui circolano patogeni come E. coli, Salmonella, Campylobacter che si trasmettono all’uomo, per i quali il rischio non è mai zero e possono persistere anche con ispezioni rigorose.
Diversamente dalle procedure manuali, la tecnologia di automazione del processo di produzione della carne coltivata all’interno di bioreattori dotati di sofisticati sistemi di monitoraggio, consente di rilevare rapidamente, tramite sensori fisico-chimici eventuali condizioni sfavorevoli nelle vasche di coltivazione, inclusi batteri patogeni, ma anche residui di ormoni ed antibiotici.
A differenza della maggior parte dei produttori di alimenti che testano i lotti in modo casuale, questo sistema offre maggiori garanzie poiché esamina ogni singolo lotto, riduce il rischio di contaminazione e aumenta il controllo, la sicurezza e la tracciabilità dei processi. In pratica, il rischio può essere facilmente monitorato utilizzando test per la quantificazione dei farmaci veterinari sulla linea cellulare e sul prodotto finito, ma soprattutto recuperando i dati sanitari degli animali donatori.
L’utilizzo della modellazione poi, offre vantaggi sostanziali in termini di riproducibilità, scalabilità e sostenibilità, riduce al minimo le materie prime, gli sprechi, la manipolazione e la dipendenza dall’operatore portando a una maggiore efficienza dei bioprocessi. Il processo dunque è progettato per soddisfare rigorosi standard normativi che garantiscono la qualità e la sicurezza. Per la produzione su larga scala, i bioreattori automatizzati operano ad alta intensità energetica e richiedono grandi quantità di acqua. Tuttavia, i bioreattori automatizzati lavorano ad alta intensità energetica e richiedono grandi quantità di acqua. Da un punto di vista della sostenibilità i relativi costi possono essere ridotti utilizzando fonti di energia rinnovabili e introducendo pratiche di riciclaggio e riutilizzo dell’acqua. In aggiunta alla sicurezza ci sono vantaggi di tipo ambientale rispetto all’agricoltura e allevamento tradizionali, che senza una corretta regolamentazione e pianificazione, favoriscono la deforestazione, sono responsabili per un terzo dell’emissione globale di gas serra proveniente dal settore della produzione alimentare (potenzialmente la carne coltivata produce il 92% in meno di emissioni) e consumano vaste risorse. I dati ci dicono che siamo nel bel mezzo di una catastrofe globale al rallentatore, ogni anno che passa, la forza distruttiva del cambiamento climatico diventa più destabilizzante e il danno umano agli animali più estremo.
Tornando al quesito sopra espresso, possiamo chiederci: l’agricoltura naturale può raggiungere la precisione della carne coltivata? E sostenibilità ma anche compassione (viene ridotta la macellazione industriale) non sono forse una definizione migliore di naturale? La scienza sta ora sfidando queste percezioni, dimostrando che il meglio può essere creato attraverso l’innovazione. La carne coltivata, forse, non è del tutto naturale, ma è più sicura, più sostenibile ed eticamente allineata con i valori moderni. Inoltre tra i suoi vantaggi, e questo va incontro alle esigenze dietetiche dei nuovi consumatori più attenti, c’è la possibilità di ottimizzarla sotto il profilo nutrizionale. La carne è ricca di acidi grassi saturi, come l’acido stearico, palmitico e laurico, questi ultimi due responsabili dell’aumento delle concentrazioni di colesterolo nel sangue, ma povera di acidi grassi polinsaturi (es. omega 3 e 6) che invece, riducono i livelli di colesterolo e con essi il rischio di subire malattie cardiovascolari. Queste sostanze più salutari potrebbero consentire di creare una prodotto proteico più funzionale e benefico per il consumatore.
Oggi alcuni prodotti che includono cellule coltivate sono stati approvati per la vendita a Singapore, Hong Kong, Stati Uniti (in pausa) e Israele, ma non ancora nei paesi dell’Unione Europea. Uma Valeti, fondatore e CEO dell’azienda Upside Foods, ha dichiarato nel 2016 che ‘l’umanità è sull’orlo del ‘secondo addomesticamento’: invece di addomesticare gli animali per produrre carne, addomestichiamo le cellule per coltivarla direttamente, un cambiamento dietetico importante quanto il passaggio dalla caccia e dalla raccolta alle colture e all’allevamento. Per il futuro sicuramente i quadri normativi sui nuovi prodotti alimentari (novel food) dissiperanno le preoccupazioni relative alla sicurezza e trasparenza dei metodi di produzione e dei potenziali impatti a lungo termine. Per migliorare l’efficacia della comunicazione con i non esperti (es. clienti, consumatori, elettori) e le parti interessate (es. allevatori, enti di regolamentazione e politici) e sviluppare un quadro unificato e multidisciplinare, occorrerà superare l’approccio frammentato e a silos della ricerca sull’agricoltura cellulare in diversi settori (es. economico, alimentare, sanitario, biotecnologico e ambientale, promuovere la collaborazione tra industria, gruppi di ricerca, mondo accademico e autorità regolatorie e condividere database scientifici. Sono necessari modelli accurati. E per averli abbiamo bisogno di dati migliori su cellule, composizione della biomassa, cinetica e consumo dei nutrienti ed efficienza energetica. Sullo sfondo di dati promettenti di una recente analisi per il contributo significativo della carne coltivata all’economia dell’UE e una elettrizzante corsa globale agli investimenti nel settore dell’ordine di miliardi di dollari da parte di capitale di rischio e fondi sovrani, nonché dei principali produttori di carne, e di start-up come East Just e Upside food, che, prima di aver superato le sfide tecnologiche più fondamentali, hanno spinto per l’approvazione del governo americano, si stagliano dichiarazioni che sottolineano come all’ampia rivoluzione della carne coltivata non corrisponda una prospettiva reale, e sicuramente non nei pochi anni che ci sono rimasti per evitare la catastrofe climatica. Dalle interviste con investitori e addetti ai lavori, tra cui molti che hanno fatto parte dei team di leadership di aziende del settore, emerge una litania di risorse sperperate, promesse non mantenute, strutture costose, significativi ostacoli tecnologici e dati scientifici non validati. Sono battute d’arresto prevedibili del ciclo hype di Gartner per l’innovazione e di sviluppo di tecnologie trasformative, che la storia ha dimostrato non seguire una linea retta. Affinché l’agricoltura cellulare raggiunga il “plateau della produttività”, non deve solo superare ostacoli di tipo biotecnologico e ingegneristico, ma anche quelli di natura sociale e politica. La carne coltivata, una idea futuristica, lungi dal ritenerla, in una prospettiva di scalabilità a lungo termine, sostitutiva di quella convenzionale, rappresenta una preziosa opportunità a fianco alle offerte vegetali e proteine alternative per realizzare una transizione proteica sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Le conseguenze disastrose del cambiamento climatico sono un wake-up che ci spinge a reinventare le nostre economie, a ripensare ai consumi e ridisegnare le nostre relazioni con la natura e l’uno con l’altro.
Parimenti è giunto il momento di ripensare alla narrativa del cibo cercando di superare la dicotomia semplicistica tra natura e innovazione scientifica e tecnologia che non riesce a catturare l’evoluzione dei moderni processi di produzione e favorire l’accettazione da parte del pubblico di soluzioni solo apparentemente innaturali come la carne coltivata.
Leggi il documento
Dott. Maurizio Ferri, Coordinatore scientifico della SIMeVeP
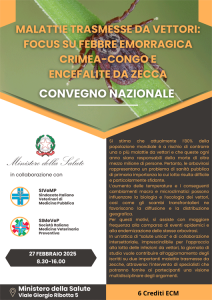
 E’ possibile rivedere l’incontro su Focus sul farmaco per gli animali d’affezione che si è tenuto il 23 gennaio u.s..e 13.30 alle 15.00 . L’incontro in collaborazione con SIMeVeP , tenuto dalla dottoressa Silvia Fiorina e dal dottor Marco Cecchetto.
E’ possibile rivedere l’incontro su Focus sul farmaco per gli animali d’affezione che si è tenuto il 23 gennaio u.s..e 13.30 alle 15.00 . L’incontro in collaborazione con SIMeVeP , tenuto dalla dottoressa Silvia Fiorina e dal dottor Marco Cecchetto. Di Francesco Tozzi
Di Francesco Tozzi “Ciò che era assolutamente impensabile, per i cambiamenti in atto può accadere. Quindi abbiamo il dovere di monitorare”. Lo ha detto Aldo Grasselli, Segretario Nazionale SIVeMP e Presidente Onorario SIMEVeP in un
“Ciò che era assolutamente impensabile, per i cambiamenti in atto può accadere. Quindi abbiamo il dovere di monitorare”. Lo ha detto Aldo Grasselli, Segretario Nazionale SIVeMP e Presidente Onorario SIMEVeP in un Possiamo immaginare un futuro scintillante di un mondo appena oltre il presente in cui la carne è abbondante e accessibile, con quasi nessun costo per l’ambiente e senza la
Possiamo immaginare un futuro scintillante di un mondo appena oltre il presente in cui la carne è abbondante e accessibile, con quasi nessun costo per l’ambiente e senza la  Ad oggi negli Stati Uniti i casi umani totali confermati di influenza aviaria H5N1 sono 66. Ricordiamo che a livello globale, negli ultimi 20 anni sono stati segnalati circa 500 decessi da H5N1, la maggior parte dei quali nel sud-est asiatico. I casi negli Stati Uniti si sono verificati principalmente in soggetti adulti con esposizione a pollame o bovini da latte infetti e con una sintomatologia consistente in congiuntivite (93% dei casi), febbre (46%) e sintomi respiratori (36%). Non è stata individuata alcuna diffusione persona-persona. Su ruolo del latte crudo, ritenuto un prodotto a rischio per l’uomo, ad oggi non ci sono segnalazioni di casi umani, sebbene il virus sia tramesso ad alcuni gatti a seguito del consumo di latte infetto.
Ad oggi negli Stati Uniti i casi umani totali confermati di influenza aviaria H5N1 sono 66. Ricordiamo che a livello globale, negli ultimi 20 anni sono stati segnalati circa 500 decessi da H5N1, la maggior parte dei quali nel sud-est asiatico. I casi negli Stati Uniti si sono verificati principalmente in soggetti adulti con esposizione a pollame o bovini da latte infetti e con una sintomatologia consistente in congiuntivite (93% dei casi), febbre (46%) e sintomi respiratori (36%). Non è stata individuata alcuna diffusione persona-persona. Su ruolo del latte crudo, ritenuto un prodotto a rischio per l’uomo, ad oggi non ci sono segnalazioni di casi umani, sebbene il virus sia tramesso ad alcuni gatti a seguito del consumo di latte infetto. Il dottor Maurizio Ferri, veterinario dirigente della Asl di Pescara, a seguito di un bando europeo pubblicato dalla commissione europea a novembre 2023, è stato selezionato e inserito nella lista di esperti (reserve list) del comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica, istituito dalla commissione europea nel 2023 con compiti di consulenza in caso di gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero e sulle misure da adottare in risposta al focolaio e sui tempi per revocarle. Il gruppo colma la grave lacuna individuata durante la pandemia di Covid 19.
Il dottor Maurizio Ferri, veterinario dirigente della Asl di Pescara, a seguito di un bando europeo pubblicato dalla commissione europea a novembre 2023, è stato selezionato e inserito nella lista di esperti (reserve list) del comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica, istituito dalla commissione europea nel 2023 con compiti di consulenza in caso di gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero e sulle misure da adottare in risposta al focolaio e sui tempi per revocarle. Il gruppo colma la grave lacuna individuata durante la pandemia di Covid 19. La SIMeVeP in collaborazione con ADMV, Associazione Donne Medico Veterinario, ha organizzato per il 18 dicembre il Webinar dal titolo “Focus sull’uso del farmaco negli animali d’affezione” tenuto dalla dottoressa Silvia Fiorina e dal dottor Marco Cecchetto del
La SIMeVeP in collaborazione con ADMV, Associazione Donne Medico Veterinario, ha organizzato per il 18 dicembre il Webinar dal titolo “Focus sull’uso del farmaco negli animali d’affezione” tenuto dalla dottoressa Silvia Fiorina e dal dottor Marco Cecchetto del  L’EFSA in un rapporto scientifico del 4 Dicembre 2024 dal titolo ‘Fattori di rischio e di protezione per la Peste suina africana nei suini domestici e nei cinghiali nell’UE e misure di mitigazione per la gestione della malattia nei cinghiali’, utilizzando revisioni delle pubblicazioni scientifiche, studi sul campo, questionari e modelli matematici, individua e valuta cinque aspetti epidemiologici della PSA.
L’EFSA in un rapporto scientifico del 4 Dicembre 2024 dal titolo ‘Fattori di rischio e di protezione per la Peste suina africana nei suini domestici e nei cinghiali nell’UE e misure di mitigazione per la gestione della malattia nei cinghiali’, utilizzando revisioni delle pubblicazioni scientifiche, studi sul campo, questionari e modelli matematici, individua e valuta cinque aspetti epidemiologici della PSA.