Ferri: PSA tra fattori di rischio e di protezione
 L’EFSA in un rapporto scientifico del 4 Dicembre 2024 dal titolo ‘Fattori di rischio e di protezione per la Peste suina africana nei suini domestici e nei cinghiali nell’UE e misure di mitigazione per la gestione della malattia nei cinghiali’, utilizzando revisioni delle pubblicazioni scientifiche, studi sul campo, questionari e modelli matematici, individua e valuta cinque aspetti epidemiologici della PSA.
L’EFSA in un rapporto scientifico del 4 Dicembre 2024 dal titolo ‘Fattori di rischio e di protezione per la Peste suina africana nei suini domestici e nei cinghiali nell’UE e misure di mitigazione per la gestione della malattia nei cinghiali’, utilizzando revisioni delle pubblicazioni scientifiche, studi sul campo, questionari e modelli matematici, individua e valuta cinque aspetti epidemiologici della PSA.
In primo luogo i risultati della revisione della letteratura e di uno studio caso-controllo negli allevamenti di suini commerciali, sottolineano l’importanza dei fattori di rischio legati alla biosicurezza e pratiche agricole, compresa la diffusione del letame intorno agli allevamenti e l’uso di materiale da lettiera, mentre l’uso di reti anti-insetti svolge una azione protettiva. Per quanto riguarda la densità dei cinghiali, ritenuto essere un fattore rilevante dal punto di vista epidemiologico, i modelli statistici e meccanicistici utilizzati non hanno evidenziato un effetto chiaro e coerente sull’epidemiologia della PSA negli scenari selezionati, diversamente da altri fattori ambientali, come vegetazione, altitudine, clima e barriere che influenzando la connettività della popolazione, svolgono un ruolo epidemiologico chiave per la PSA nei cinghiali.
Riguardo alla presenza e sorveglianza di Ornithodoros erraticus sembra che questa zecca non abbia avuto alcun ruolo nell’attuale epidemia di PSA nelle aree colpite dell’UE. Le prove scientifiche disponibili suggeriscono invece che le mosche delle stalle e i tafani sono esposti alla PSA, hanno la capacità di introdurre l’infezione negli allevamenti e trasmetterla ai suini, anche se non è chiaro se ciò si verifichi e, in caso affermativo, in che misura.
Molto si è parlato delle recinzioni, ricordiamo quelle costruite in Danimarca lungo i confini con la Germania, dopo i primi focolai in quest’ultimo paese nel 2020 nei cinghiali nelle zone immediatamente adiacenti al confine con la Polonia. Ebbene la ricerca e l’esperienza sul campo dei paesi colpiti nell’UE dimostrano che il loro uso, potenzialmente abbinato alle infrastrutture stradali esistenti, insieme ad altri metodi di controllo come l’abbattimento e la rimozione delle carcasse di cinghiali, può ridurre efficacemente i movimenti dei cinghiali contribuendo alla gestione della PSA in natura. Le recinzioni possono contribuire a controllare l’infezione in entrambi gli scenari di introduzioni focali e diffusione a onde. In ultimo, i vaccini. Si è dimostrato che l’uso dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH) come contraccettivo immunitario, ha il potenziale, come strumento complementare, di ridurre e controllare le popolazioni di cinghiali. Tuttavia, lo sviluppo di un vaccino orale GnRH per i cinghiali richiede ulteriori studi scientifici.
Dott. Maurizio Ferri, Coordinatore scientifico della SIMeVeP
 Il virus dell’influenza aviare H5N1 corre e acquisisce mutazioni di adattamento ai mammiferi con il rischio di una nuova potenziale pandemia.
Il virus dell’influenza aviare H5N1 corre e acquisisce mutazioni di adattamento ai mammiferi con il rischio di una nuova potenziale pandemia.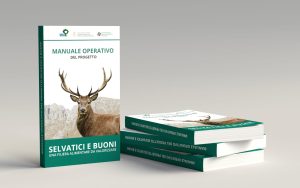 Giovedì 9 maggio alle ore 13.00 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati sarà presentato il Manuale operativo del progetto “Selvatici e buoni – Una filiera alimentare da valorizzare” sostenuto dalla Fondazione UNA Onlus (Uomo Natura Ambiente) che vede capofila l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo in collaborazione con il Dipartimento di Medicinaveterinaria dell’Università degli Studi di Milano e la Società italiana di Medicina veterinaria preventiva.
Giovedì 9 maggio alle ore 13.00 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati sarà presentato il Manuale operativo del progetto “Selvatici e buoni – Una filiera alimentare da valorizzare” sostenuto dalla Fondazione UNA Onlus (Uomo Natura Ambiente) che vede capofila l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo in collaborazione con il Dipartimento di Medicinaveterinaria dell’Università degli Studi di Milano e la Società italiana di Medicina veterinaria preventiva. Il cervo è un ungulato selvatico diffuso su tutta la penisola italiana, con una popolazione in crescita favorita dalla carenza di predatori e dal progressivo abbandono delle aree marginali da parte dell’uomo. L’aumento della sua presenza comporta un parallelo aumento delle interazioni con l’uomo e con gli animali domestici sia in modo diretto che indiretto; ne sono un esempio la condivisione dei pascoli montani con il bestiame domestico e l’uso della sua carne nell’alimentazione umana. Questo animale è sospettato di diffondere e mantenere la tubercolosi bovina, malattia per la quale alcuni Paesi europei non riescono ad ottenere lo status di indennità nonostante i notevoli sforzi e investimenti.
Il cervo è un ungulato selvatico diffuso su tutta la penisola italiana, con una popolazione in crescita favorita dalla carenza di predatori e dal progressivo abbandono delle aree marginali da parte dell’uomo. L’aumento della sua presenza comporta un parallelo aumento delle interazioni con l’uomo e con gli animali domestici sia in modo diretto che indiretto; ne sono un esempio la condivisione dei pascoli montani con il bestiame domestico e l’uso della sua carne nell’alimentazione umana. Questo animale è sospettato di diffondere e mantenere la tubercolosi bovina, malattia per la quale alcuni Paesi europei non riescono ad ottenere lo status di indennità nonostante i notevoli sforzi e investimenti. Antropocene è il nome proposto per l’attuale epoca geologica, epoca nella quale l’essere umano con le sue attività è riuscito a incidere sui processi naturali e modificare ambiente ed ecosistemi.
Antropocene è il nome proposto per l’attuale epoca geologica, epoca nella quale l’essere umano con le sue attività è riuscito a incidere sui processi naturali e modificare ambiente ed ecosistemi. Giunta (SIMeVeP): “Carne sicura. Basta cuocerla. I Medici Veterinari della Asl Foggia stanno controllando le macellerie locali: nessun caso di positività alla trichinosi tra i campioni esaminati”.
Giunta (SIMeVeP): “Carne sicura. Basta cuocerla. I Medici Veterinari della Asl Foggia stanno controllando le macellerie locali: nessun caso di positività alla trichinosi tra i campioni esaminati”. Sorice (SIMeVeP): «La vaccinazione destinata agli animali è già pronta all’uso. Non escluso che, presto, per evitare il diffondersi di altri focolai, le autorità competenti decideranno di mettere a disposizioni le dosi necessarie per vaccinare gli animali presenti nei nostri allevamenti»
Sorice (SIMeVeP): «La vaccinazione destinata agli animali è già pronta all’uso. Non escluso che, presto, per evitare il diffondersi di altri focolai, le autorità competenti decideranno di mettere a disposizioni le dosi necessarie per vaccinare gli animali presenti nei nostri allevamenti» Come già affermato in diverse occasioni proprio in questa rubrica, nel nostro Paese, le questioni legate all’esplosione demografica delle popolazioni di cinghiali sono sempre di estrema attualità con prese di posizione, quasi sempre divergenti, tra chi si ritiene danneggiato dalla loro esuberante presenza – in primis gli agricoltori – e chi invece – in primis le associazioni animaliste – osteggia qualunque intervento venga anche solo ipotizzato per ridurne la invadente e assai spesso pericolosa presenza (in primis incidenti stradali).
Come già affermato in diverse occasioni proprio in questa rubrica, nel nostro Paese, le questioni legate all’esplosione demografica delle popolazioni di cinghiali sono sempre di estrema attualità con prese di posizione, quasi sempre divergenti, tra chi si ritiene danneggiato dalla loro esuberante presenza – in primis gli agricoltori – e chi invece – in primis le associazioni animaliste – osteggia qualunque intervento venga anche solo ipotizzato per ridurne la invadente e assai spesso pericolosa presenza (in primis incidenti stradali). È stato confermato dalla Commissione sanitaria cinese il primo caso conosciuto di contagio umano del ceppo H3N8 di influenza aviaria. Si tratta di un bambino di quattro anni della regione di Henan, ricoverato in ospedale da poco meno di un mese con febbre ed altri sintomi. Il piccolo paziente proviene da un contesto familiare rurale, che vive a stretto contatto con polli e altri volatili selvatici. È probabile, quindi, che il contagio sia avvenuto per contatto diretto con un animale infetto. A quanto pare, inoltre, nessuno degli altri componenti della famiglia risulterebbe contagiato.
È stato confermato dalla Commissione sanitaria cinese il primo caso conosciuto di contagio umano del ceppo H3N8 di influenza aviaria. Si tratta di un bambino di quattro anni della regione di Henan, ricoverato in ospedale da poco meno di un mese con febbre ed altri sintomi. Il piccolo paziente proviene da un contesto familiare rurale, che vive a stretto contatto con polli e altri volatili selvatici. È probabile, quindi, che il contagio sia avvenuto per contatto diretto con un animale infetto. A quanto pare, inoltre, nessuno degli altri componenti della famiglia risulterebbe contagiato.