 L’ENEA, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, ha messo a punto un innovativo biopesticida che protegge le api. Alla base del nuovo “antiparassitario” ci sono le biotecnologie, o meglio la tecnica dell’RNA interferente, che sfrutta un meccanismo naturale presente in organismi vegetali e animali per portare alla perdita di funzionalità un gene bersaglio, fondamentale per la sopravvivenza o la fertilità dell’insetto. Negli ultimi 10-15 anni, gli apicoltori europei hanno segnalato un’insolita diminuzione del numero di api e perdite di colonie, in particolare nei Paesi dell’Europa occidentale, tra cui l’Italia. Come spiega Salvatore Arpaia, ricercatore della Divisione ENEA di Bioenergia, bioraffineria e chimica verde, tante sono le cause: “l’agricoltura intensiva, l’uso di pesticidi, la perdita di habitat, i virus ma anche gli attacchi di agenti patogeni e specie invasive come l’acaro Varroa destructor, da anni presente in tutta Italia e, di recente, il calabrone asiatico Vespa velutina e il piccolo coleottero dell’alveare Aethina tumida che, al momento, ha una diffusione territoriale circoscritta alla parte più meridionale della Calabria”. L’innovativo biopesticida è stato testato proprio in questa regione, presso la sezione dell’Istituto Zooprofilattico di Reggio Calabria, dove il coleottero viene mantenuto in allevamento sottoposto a stringenti misure di contenimento. “I risultati ottenuti – precisa Arpaia – indicano chiaramente che la somministrazione per ingestione del nostro biopesticida, che si avvale dell’azione di molecole di RNA a doppio filamento specifiche contro due geni di Aethina tumida, induce effetti anti-metabolici sullo sviluppo e sulla riproduzione del coleottero. Infatti, le larve alimentate con dieta contenente le molecole che abbiamo sintetizzato nei nostri laboratori ENEA di Trisaia, in Basilicata, soffrono di un decremento nel tasso di sviluppo, di un rallentamento nel ciclo biologico e, da adulti, di una sensibile riduzione della fertilità. La coesistenza di questi tre effetti in una popolazione in natura porta a un prevedibile rapido contenimento dei danni del coleottero a carico dell’alveare, della produzione apistica, senza alcun rischio per l’ambiente e per l’uomo.
L’ENEA, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, ha messo a punto un innovativo biopesticida che protegge le api. Alla base del nuovo “antiparassitario” ci sono le biotecnologie, o meglio la tecnica dell’RNA interferente, che sfrutta un meccanismo naturale presente in organismi vegetali e animali per portare alla perdita di funzionalità un gene bersaglio, fondamentale per la sopravvivenza o la fertilità dell’insetto. Negli ultimi 10-15 anni, gli apicoltori europei hanno segnalato un’insolita diminuzione del numero di api e perdite di colonie, in particolare nei Paesi dell’Europa occidentale, tra cui l’Italia. Come spiega Salvatore Arpaia, ricercatore della Divisione ENEA di Bioenergia, bioraffineria e chimica verde, tante sono le cause: “l’agricoltura intensiva, l’uso di pesticidi, la perdita di habitat, i virus ma anche gli attacchi di agenti patogeni e specie invasive come l’acaro Varroa destructor, da anni presente in tutta Italia e, di recente, il calabrone asiatico Vespa velutina e il piccolo coleottero dell’alveare Aethina tumida che, al momento, ha una diffusione territoriale circoscritta alla parte più meridionale della Calabria”. L’innovativo biopesticida è stato testato proprio in questa regione, presso la sezione dell’Istituto Zooprofilattico di Reggio Calabria, dove il coleottero viene mantenuto in allevamento sottoposto a stringenti misure di contenimento. “I risultati ottenuti – precisa Arpaia – indicano chiaramente che la somministrazione per ingestione del nostro biopesticida, che si avvale dell’azione di molecole di RNA a doppio filamento specifiche contro due geni di Aethina tumida, induce effetti anti-metabolici sullo sviluppo e sulla riproduzione del coleottero. Infatti, le larve alimentate con dieta contenente le molecole che abbiamo sintetizzato nei nostri laboratori ENEA di Trisaia, in Basilicata, soffrono di un decremento nel tasso di sviluppo, di un rallentamento nel ciclo biologico e, da adulti, di una sensibile riduzione della fertilità. La coesistenza di questi tre effetti in una popolazione in natura porta a un prevedibile rapido contenimento dei danni del coleottero a carico dell’alveare, della produzione apistica, senza alcun rischio per l’ambiente e per l’uomo.
Quali le conseguenze sulle api e sulla loro salute?
“Per quanto riguarda la salvaguardia della salute delle api sottoposte a trattamento con un insetticida a base di dsRNA, è stata fatta una prima valutazione con un’analisi di similarità delle sequenze fra i due dsRNA utilizzati e il genoma di Apis mellifera, che risulta completamente sequenziato. La bassissima similarità rivelata dall’analisi BLAST porta a escludere eventuali effetti dovuti alla sequenza utilizzata. Per valutare la possibilità di effetti off-target sulle api, sarà necessario procedere a una successiva prova in vivo, anche se le evidenze disponibili in letteratura riferite ad altri dsRNA indicano che l’ape è generalmente poco sensibile al silenziamento genico indotto dalle molecole che abbiamo utilizzato”, spiega il ricercatore ENEA.
Chi è l’Aethina tumida
Il piccolo coleottero dell’alveare, infestante delle colonie di Apis mellifera, è un insetto della famiglia Nitidulidae e dell’ordine dei Coleoptera, specie originaria del Sud Africa ed endemica delle regioni tropicali e subtropicali dell’Africa Sub-sahariana; è stata rinvenuta per la prima volta in Europa, in Calabria, nel settembre del 2014. L’insetto è inserito nell’elenco del Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH come patologia emergente delle api ed è soggetta a notifica internazionale. Inoltre, è inserito nell’allegato II del Reg. Ue 429/2016 che dispone l’obbligo di notifica e misure per l’eradicazione. Per contenerne la diffusione in Europa, sono in atto importanti misure restrittive che comportano la cessazione del nomadismo (inclusa la rilevante opera di supporto all’impollinazione in frutticoltura), il commercio delle colonie al di fuori dell’area infestata dal coleottero, il monitoraggio periodico degli alveari e, in molti casi, la distruzione delle colonie.
Fonte: Vet33
 Il 19 settembre 2022 i servizi veterinari della regione Junta in Andalusia, Spagna, hanno notificato al WOAH un focolaio di vaiolo ovino e caprino in un allevamento ovino da riproduzione situato nel comune di Benamaurel, nella provincia di Granada.
Il 19 settembre 2022 i servizi veterinari della regione Junta in Andalusia, Spagna, hanno notificato al WOAH un focolaio di vaiolo ovino e caprino in un allevamento ovino da riproduzione situato nel comune di Benamaurel, nella provincia di Granada. SARS CoV-2 negli animali, un sito per navigare in tutti gli eventi segnalati.
SARS CoV-2 negli animali, un sito per navigare in tutti gli eventi segnalati. È stato rilevato per la prima volta nel Nord-est Italia il virus dell’RHDV2 in un esemplare di lepre bruna europea. L’animale, ritrovato morto nella Riserva di Ala (provincia di Trento) a giugno 2022, è stato conferito alla
È stato rilevato per la prima volta nel Nord-est Italia il virus dell’RHDV2 in un esemplare di lepre bruna europea. L’animale, ritrovato morto nella Riserva di Ala (provincia di Trento) a giugno 2022, è stato conferito alla  La stagione epidemica 2021-2022 dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è la più grande finora osservata in Europa. Gli ultimi dati del rapporto congiunto dell’EFSA, dell’ECDC e del laboratorio di riferimento dell’UE mostrano un totale di 2.467 focolai nel pollame, 48 milioni di uccelli abbattuti negli stabilimenti colpiti, 187 rilevamenti negli uccelli in cattività e 3.573 eventi HPAI negli uccelli selvatici. Inoltre, l’estensione geografica dell’epidemia è senza precedenti, dalle isole Svalbard al Portogallo meridionale e dall’est all’Ucraina, colpendo 37 paesi europei.
La stagione epidemica 2021-2022 dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è la più grande finora osservata in Europa. Gli ultimi dati del rapporto congiunto dell’EFSA, dell’ECDC e del laboratorio di riferimento dell’UE mostrano un totale di 2.467 focolai nel pollame, 48 milioni di uccelli abbattuti negli stabilimenti colpiti, 187 rilevamenti negli uccelli in cattività e 3.573 eventi HPAI negli uccelli selvatici. Inoltre, l’estensione geografica dell’epidemia è senza precedenti, dalle isole Svalbard al Portogallo meridionale e dall’est all’Ucraina, colpendo 37 paesi europei.
 E’ attiva nella Banca Dati Nazionale la nuova funzionalità per gli allevamenti autorizzati alle movimentazioni.
E’ attiva nella Banca Dati Nazionale la nuova funzionalità per gli allevamenti autorizzati alle movimentazioni. L’ENEA, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, ha messo a punto un innovativo biopesticida che protegge le api. Alla base del nuovo “antiparassitario” ci sono le biotecnologie, o meglio la tecnica dell’RNA interferente, che sfrutta un meccanismo naturale presente in organismi vegetali e animali per portare alla perdita di funzionalità un gene bersaglio, fondamentale per la sopravvivenza o la fertilità dell’insetto. Negli ultimi 10-15 anni, gli apicoltori europei hanno segnalato
L’ENEA, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, ha messo a punto un innovativo biopesticida che protegge le api. Alla base del nuovo “antiparassitario” ci sono le biotecnologie, o meglio la tecnica dell’RNA interferente, che sfrutta un meccanismo naturale presente in organismi vegetali e animali per portare alla perdita di funzionalità un gene bersaglio, fondamentale per la sopravvivenza o la fertilità dell’insetto. Negli ultimi 10-15 anni, gli apicoltori europei hanno segnalato  Sulla base di analisi genetiche condotte contemporaneamente su zanzare, uccelli e uomo, i ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie hanno verificato che in Veneto circolano due ceppi di virus West Nile, denominati WNV-1 e WNV-2.
Sulla base di analisi genetiche condotte contemporaneamente su zanzare, uccelli e uomo, i ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie hanno verificato che in Veneto circolano due ceppi di virus West Nile, denominati WNV-1 e WNV-2. Il servizio di sanità pubblica veterinaria dell’Azienda Asl Toscana sud est di Arezzo comunica che in data 25 agosto l’Istituto Zooprofilattico di Roma ha refertato la positività al virus Usutu su alcuni esemplari di uccelli selvatici rinvenuti morti presso l’area di tiro a segno di Talzano nel comune di Arezzo.
Il servizio di sanità pubblica veterinaria dell’Azienda Asl Toscana sud est di Arezzo comunica che in data 25 agosto l’Istituto Zooprofilattico di Roma ha refertato la positività al virus Usutu su alcuni esemplari di uccelli selvatici rinvenuti morti presso l’area di tiro a segno di Talzano nel comune di Arezzo.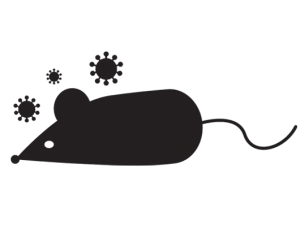 Un nuovo virus animale in grado di infettare le persone è stato identificato nella Cina orientale.
Un nuovo virus animale in grado di infettare le persone è stato identificato nella Cina orientale.