IZSVe e IZSAM nominati Centro di referenza FAO per i coronavirus zoonotici

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali delle Venezie (IZSVe) e dell’Abruzzo e Molise (IZSAM) sono stati nominati Centro di referenza FAO per i coronavirus zoonotici.
Con la nomina la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ha valutato positivamente l’expertise scientifica dei due Istituti Zooprofilattici italiani, confermandoli poli di eccellenza per la ricerca biomedica e la sanità pubblica veterinaria.
“Siamo molto orgogliosi di questo importante riconoscimento che rafforza ancora di più lo spessore dell’Istituto a livello internazionale” dichiara la Dg dell’IZSVe Antonia Ricci. “In questi anni abbiamo puntato sullo sviluppo di linee di ricerca innovative e sullo studio di malattie emergenti. Questo è un risultato di tutto l’Istituto che abbiamo raggiunto grazie a competenze scientifiche di altissimo livello e alla capacità di fare rete a livello internazionale. Il mio ringraziamento va al Ministero della salute che ha fortemente sostenuto le nostre candidature presso le agenzie internazionali”.
Il Centro di referenza FAO per i coronavirus zoonotici è stato assegnato all’IZSVe e all’IZSAM per un periodo di quattro anni, sotto la direzione del dott. Francesco Bonfante, veterinario dirigente e responsabile del Laboratorio ricerca modelli animali presso la SCS6 – Virologia speciale e sperimentazione dell’IZSVe. Il vicedirettore del Centro di Referenza è il dott. Alessio Lorusso, veterinario dirigente del reparto Virologia e colture cellulari dell’IZS di Teramo. La candidatura comune dei due Istituti come Centro di Referenza FAO rappresenta il coronamento di una lunga e proficua collaborazione nell’ambito dello studio e della ricerca nel campo della virologia veterinaria.
Durante la pandemia da SARS-CoV-2 l’IZSVe ha contribuito a monitorare la circolazione del virus nel comparto zootecnico italiano e negli animali domestici, coordinando a livello nazionale attività di sorveglianza e di ricerca di numerosi Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Nonostante la straordinarietà degli eventi, l’IZSVe ha reagito all’emergenza pandemica con grande incisività, facendo tesoro della decennale esperienza nella gestione delle epidemie animali e nel monitoraggio degli agenti virali emergenti con potenziale zoonotico. In particolare, ha formato équipe di ricercatori in grado di studiare i meccanismi di spillover di diversi patogeni con potenziale pandemico (influenza aviaria, coronavirus animali) dalla fauna selvatica agli animali domestici, in una prospettiva One Health.
Grazie alla sua organizzazione, al know-how, alla disponibilità di laboratori specializzati e infrastrutture informatiche capaci di gestire al meglio le operazioni di ricezione, analisi e refertazione dei campioni, l’IZSAM è stato operativo nella lotta contro la pandemia sin dall’inizio dell’emergenza, da marzo del 2020. L’IZS di Teramo ha investito subito nell’acquisto di strumenti altamente tecnologici, si è dotato di un nuovo laboratorio ad alto contenimento biologico e ha svolto oltre il 60% dell’intera attività analitica della Regione Abruzzo, arrivando a processare 4.500 campioni al giorno. Contestualmente ha portato avanti attività di ricerca su più fronti come il sequenziamento del genoma del virus mediante metodiche di nuova generazione (NGS) che, a fine 2020, ha permesso di rilevare la cosiddetta variante inglese, quella brasiliana e consente il monitoraggio costante delle mutazioni di rilevanza clinica ed epidemiologica.
“Nelle prime fasi della pandemia ci siamo spesi con tutte le forze nell’attività analitica, supportando non solo le ASL del nostro territorio di competenza ma anche la ATS di Bergamo. Di pari passo abbiamo intensificato la ricerca” afferma il DG dell’IZS di Teramo Nicola D’Alterio, “ad esempio attraverso l’analisi genomica, fondamentale per mappare in tempo reale le varianti e intercettare le nuove mutazioni del virus. Abbiamo sempre adottato un approccio One Health, che ci contraddistingue in tutte le nostre attività, avviando collaborazioni interdisciplinari in Italia e nel resto del Mondo, come in Africa. All’IZS delle Venezie ci lega un rapporto di stima reciproca e stretta collaborazione scientifica” conclude D’Alterio, “aver ottenuto insieme questo importante riconoscimento da parte della FAO premia non solo il nostro lavoro ma quello di tutti gli IIZZSS italiani, coordinati perfettamente dal Ministero della salute”.
Fra i compiti del nuovo Centro FAO vi sono innanzitutto la valutazione e la gestione del rischio di circolazione di coronavirus zoonotici negli animali, da attuarsi mediante attività di sorveglianza e studi di caratterizzazione della patogenicità e trasmissibilità del virus. Inoltre il Centro darà supporto tecnico-scientifico a diversi Paesi del continente africano e del Medio Oriente, al fine di potenziare la capacità della comunità scientifica internazionale di intercettare prontamente la circolazione di coronavirus zoonotici, emersi o emergenti, a livello di fauna selvatica e di animali domestici.
Fonte: IZS Venezie
 Sulla base di analisi genetiche condotte contemporaneamente su zanzare, uccelli e uomo, i ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie hanno verificato che in Veneto circolano due ceppi di virus West Nile, denominati WNV-1 e WNV-2.
Sulla base di analisi genetiche condotte contemporaneamente su zanzare, uccelli e uomo, i ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie hanno verificato che in Veneto circolano due ceppi di virus West Nile, denominati WNV-1 e WNV-2. Una collaborazione tra ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’IRBM e del CNR ha identificato grazie ad una combinazione di metodi innovativi nuove molecole che bloccano la trasmissione del parassita della malaria dalla persona infetta alla zanzara, primo passo per sviluppare nuovi farmaci per eliminare questa grave malattia infettiva. Lo studio è stato
Una collaborazione tra ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’IRBM e del CNR ha identificato grazie ad una combinazione di metodi innovativi nuove molecole che bloccano la trasmissione del parassita della malaria dalla persona infetta alla zanzara, primo passo per sviluppare nuovi farmaci per eliminare questa grave malattia infettiva. Lo studio è stato  Se qualcuno pensava che la “saga delle bufale mediatiche” avesse toccato l’apice con la pandemia da Covid-19, per la quale la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità aveva coniato l’espressione “infodemia”, quel qualcuno s’illudeva alla grande!
Se qualcuno pensava che la “saga delle bufale mediatiche” avesse toccato l’apice con la pandemia da Covid-19, per la quale la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità aveva coniato l’espressione “infodemia”, quel qualcuno s’illudeva alla grande! Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha pubblicato una
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha pubblicato una 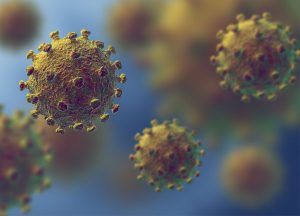 SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile della COVID-19, può sopravvivere sulle superfici fino a 28 giorni, più di tutti gli altri coronavirus. La sopravvivenza del virus e la sua contagiosità sono inoltre influenzate dalle condizioni ambientali. Lo afferma una revisione sistematica della letteratura condotta dai ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e pubblicata su
SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile della COVID-19, può sopravvivere sulle superfici fino a 28 giorni, più di tutti gli altri coronavirus. La sopravvivenza del virus e la sua contagiosità sono inoltre influenzate dalle condizioni ambientali. Lo afferma una revisione sistematica della letteratura condotta dai ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e pubblicata su  Mucche, gorilla e orsi sono a più alto rischio di contagiarsi di di SARS-CoV-2. Più in generale, tutte le specie a stretto contatto con l’uomo. A scoprirlo, lo studio del Cary Institute of Ecosystem Studies,
Mucche, gorilla e orsi sono a più alto rischio di contagiarsi di di SARS-CoV-2. Più in generale, tutte le specie a stretto contatto con l’uomo. A scoprirlo, lo studio del Cary Institute of Ecosystem Studies,  Ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) hanno diagnosticato il primo caso di encefalite da zecca (TBE, Tick Borne Encephalitis) in un capriolo, in provincia di Belluno, area in cui la malattia è endemica. Finora non erano mai stati segnalati casi clinici di virus TBE nei cervidi. Questo caso, oltre all’interesse in termini di diagnosi differenziale, riporta l’attenzione sull’importanza della sorveglianza epidemiologica delle zoonosi in un ambiente in costante trasformazione. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica
Ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) hanno diagnosticato il primo caso di encefalite da zecca (TBE, Tick Borne Encephalitis) in un capriolo, in provincia di Belluno, area in cui la malattia è endemica. Finora non erano mai stati segnalati casi clinici di virus TBE nei cervidi. Questo caso, oltre all’interesse in termini di diagnosi differenziale, riporta l’attenzione sull’importanza della sorveglianza epidemiologica delle zoonosi in un ambiente in costante trasformazione. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica 
