Le intriganti traiettorie del virus influenzale AH5N1 fra animali e uomo
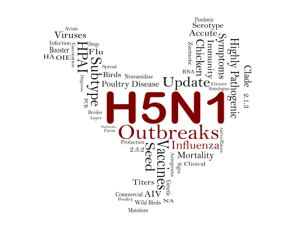 Mentre il betacoronavirus SARS-CoV-2 non smette di mostrarci la sua straordinaria capacità di soggiacere a mutazioni del proprio “make-up” genetico, risultando via via più abile ad eludere l’immunità conferita dalle pregresse infezioni e/o dalle vaccinazioni anti-COVID-19, oltre ad accrescere la propria affinità di legame nei confronti del recettore ACE-2 – come chiaramente testimoniato dalla sottovariante Omicron XBB.1.5, alias “Kraken” -, il virus AH5N1 è balzato ancora una volta agli onori della cronaca.
Mentre il betacoronavirus SARS-CoV-2 non smette di mostrarci la sua straordinaria capacità di soggiacere a mutazioni del proprio “make-up” genetico, risultando via via più abile ad eludere l’immunità conferita dalle pregresse infezioni e/o dalle vaccinazioni anti-COVID-19, oltre ad accrescere la propria affinità di legame nei confronti del recettore ACE-2 – come chiaramente testimoniato dalla sottovariante Omicron XBB.1.5, alias “Kraken” -, il virus AH5N1 è balzato ancora una volta agli onori della cronaca.
Infatti, dopo la prima apparizione nel sud-est asiatico, un quarto di secolo fa, di questo virus influenzale ad elevata patogenicita’ (“High Pathogenicity Avian Influenza virus“, “HPAI virus”), che a seguito dello “spillover” dai volatili domestici (polli) aveva già prodotto una serie di casi di malattia umana – numerosi dei quali anche ad esito fatale -, quello che al momento desta una certa preoccupazione e’ il ceppo virale noto con la sigla “2.3.4.4b”.
A testimonianza di ciò, la presenza di questo virus è stata finora segnalata in Asia, così come in Africa, Europa e Nord-America, in numerose specie di avifauna selvatica, attraverso le cui attività migratorie l’agente patogeno si sarebbe quindi trasmesso ad altre specie, ivi compresi i mammiferi marini ed i visoni d’allevamento. Questi ultimi, sulla scorta di quanto e’ stato recentemente documentato in un allevamento intensivo della regione spagnola della Galizia, avrebbero acquisito il virus da gabbiani infetti, dopodiché lo avrebbero diffusamente propagato in forma mutata tra i propri conspecifici. A tal proposito, non può non sovvenire in mente un parallelo rispetto a quanto accaduto durante la pandemia da SARS-CoV-2 in Danimarca e nei Paesi Bassi, nei cui allevamenti intensivi si sarebbe sviluppata la variante “cluster 5”, previa acquisizione del virus umano da parte dei visoni (“viral spillover“), che avrebbero successivamente propagato al proprio interno e quindi “restituito” lo stesso all’uomo in forma mutata (“viral spillback“).
Per quanto riguarda i mammiferi marini, il cui stato di salute e di conservazione risulta sempre più minacciato per mano dell’uomo e la cui suscettibilità nei confronti dei virus influenzali era già stata dimostrata da vari studi pubblicati nel corso degli ultimi 40 anni, il virus 2.3.4.4b e’ stato recentemente identificato in alcuni esemplari di focena e di tursiope, nonché in leoni marini ed in esemplari di foca rinvenuti spiaggiati lungo le coste statunitensi della Florida, oltre che su quelle del Perù e della Svezia.
Particolarmente degno di nota, in questi animali, lo spiccato neurotropismo del virus, denotato dai gravi quadri di meningo-encefalite emersi grazie alle approfondite indagini post mortem effettuate sui medesimi.
Per quanto riguarda la nostra specie, i casi d’infezione da HPAI virus AH5N1 documentati dal 2003 sino alla fine dello scorso anno ammonterebbero ad oltre 800, con la metà degli stessi ad esito infausto. Da notare, in un siffatto contesto, il caso recentemente accertato in una ragazza undicenne della Cambogia, il cui exitus non sarebbe stato tuttavia causato dal ceppo 2.3.4.4b.
Il consistente quanto rapido e progressivo ampliamento del “range” delle specie suscettibili al virus AH5N1 e, segnatamente, al “clade” 2.3.4.4b costituisce un motivo di fondato allarme, tanto più alla luce delle notevoli distanze filogenetiche intercorrenti fra volatili e mammiferi terrestri ed acquatici sensibili, oltre che della comparsa di uno stipite virale mutato nei visoni allevati intensivamente in Spagna, fra i quali l’agente patogeno si sarebbe diffusamente e celermente propagato.
Sebbene allo stato attuale delle conoscenze non risulti che il virus AH5N1 abbia finora acquisito la capacità di trasmettersi efficacemente da uomo a uomo una volta che lo stesso sia stato acquisito ad opera di animali infetti (figure professionali particolarmente a rischio sarebbero rappresentate, in proposito, dai Medici Veterinari e dalle maestranze operanti negli allevamenti e nei macelli avicoli, nonché dagli addetti al trasporto di volatili vivi), la formidabile capacità di ricombinazione e riassortimento genetico insita nell’RNA multi-segmentato dei virus influenzali conferirebbe un’elevata plausibilita’ biologica ad una siffatta evenienza.
Il salvifico principio della “One Health” – la salute unica di uomo, animali ed ambiente – dovrebbe rappresentare ancora una volta, come la drammatica pandemia da SARS-CoV-2 ci ha insegnato, il “minimo comune denominatore”, alias la stella polare attorno alla quale dovrebbe svilupparsi la sorveglianza epidemiologica nei confronti dell’infezione sostenuta dal virus AH5N1, in un clima di piena, mutua ed incondizionata trasparenza e collaborazione interdisciplinare, a garanzia del quale la divulgazione e lo scambio di sequenze virali fra i vari laboratori pubblici coinvolti su scala globale costituisce un fondamentale, ineludibile presupposto.
Giovanni Di Guardo
Già Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo
 Negli ultimi dieci anni Mycoplasma gallisepticum ha cambiato la sua sensibilità verso molti dei farmaci più comunemente prescritti per il suo contenimento. Lo afferma uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto
Negli ultimi dieci anni Mycoplasma gallisepticum ha cambiato la sua sensibilità verso molti dei farmaci più comunemente prescritti per il suo contenimento. Lo afferma uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto Dopo gli eventi di
Dopo gli eventi di  Risale a pochi giorni fa, ad opera di un team di ricercatori australiani dell’Università di Sydney, la notizia relativa all’identificazione di un ulteriore recettore nei confronti di SARS-CoV-2 – il famigerato betacoronavirus responsabile della drammatica pandemia da COVID-19 -, localizzato in ambito polmonare nonché a livello delle prime vie aeree e di altri distretti tissutali dell’ospite, ivi compresa la cute.
Risale a pochi giorni fa, ad opera di un team di ricercatori australiani dell’Università di Sydney, la notizia relativa all’identificazione di un ulteriore recettore nei confronti di SARS-CoV-2 – il famigerato betacoronavirus responsabile della drammatica pandemia da COVID-19 -, localizzato in ambito polmonare nonché a livello delle prime vie aeree e di altri distretti tissutali dell’ospite, ivi compresa la cute.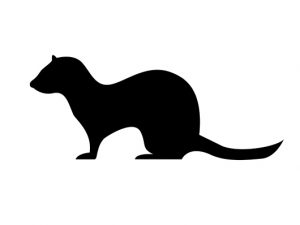 I ricercatori del
I ricercatori del  In data 11/01/2023, nel Regno Unito è stato confermato l’isolamento di Seneca Valley Virus (SVV) in 5 suini che presentavano lesioni vescicolari, identificate nel corso del 2022. L’introduzione di questo virus, segnalato per la prima volta in Europa, pone le basi per lo sviluppo di un’attività di monitoraggio e diagnosi. La sua rilevanza risiede nella possibilità di essere indagato nella diagnosi differenziale nei confronti di afta, malattia vescicolare del suino e stomatite vescicolare. Tale aspetto riveste un’importanza strategica per l’IZSLER nel controllo delle malattie vescicolari. SVV appartiene alla famiglia dei Picornaviridae ed è originario del Nord America. Il primo isolamento risale al 2002 come risultato di una contaminazione accidentale di una linea cellulare, ma studi retrospettivi hanno dimostrato la sua circolazione negli USA fin dagli anni ’80.
In data 11/01/2023, nel Regno Unito è stato confermato l’isolamento di Seneca Valley Virus (SVV) in 5 suini che presentavano lesioni vescicolari, identificate nel corso del 2022. L’introduzione di questo virus, segnalato per la prima volta in Europa, pone le basi per lo sviluppo di un’attività di monitoraggio e diagnosi. La sua rilevanza risiede nella possibilità di essere indagato nella diagnosi differenziale nei confronti di afta, malattia vescicolare del suino e stomatite vescicolare. Tale aspetto riveste un’importanza strategica per l’IZSLER nel controllo delle malattie vescicolari. SVV appartiene alla famiglia dei Picornaviridae ed è originario del Nord America. Il primo isolamento risale al 2002 come risultato di una contaminazione accidentale di una linea cellulare, ma studi retrospettivi hanno dimostrato la sua circolazione negli USA fin dagli anni ’80.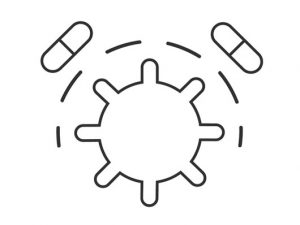 Le malattie infettive sono da lungo tempo considerate una priorità di salute pubblica globale a causa del loro forte impatto in termini di salute sulla popolazione. Prima i vaccini e poi gli antibiotici ne hanno modificato la storia, riducendo notevolmente la circolazione dei patogeni e la mortalità per malattie infettive trasmissibili.
Le malattie infettive sono da lungo tempo considerate una priorità di salute pubblica globale a causa del loro forte impatto in termini di salute sulla popolazione. Prima i vaccini e poi gli antibiotici ne hanno modificato la storia, riducendo notevolmente la circolazione dei patogeni e la mortalità per malattie infettive trasmissibili. Conoscere meglio Sars-CoV-2, a partire dalla caratterizzazione delle sue varianti e dei meccanismi di diffusione e patogenicità fino all’individuazione di strategie innovative per la diagnosi, la prevenzione e la cura. E’ questo lo spirito del bando per il finanziamento di progetti di ricerca biennali, del valore di 4 milioni di euro (finanziati dal Ministero della Salute attraverso ISS), appena pubblicato nell’ambito del progetto “Rete Italiana per la sorveglianza virologica, il monitoraggio immunologico, la formazione e la ricerca in Preparazione alla gestione delle Emergenze Infettive – R.I.Pr.E.I.”. Al bando possono partecipare ricercatori che operano presso Università, Enti di Ricerca, Enti del Ssn e Sanità militare. Sono previsti finanziamenti sia per progetti pilota, monocentrici, dedicati a idee innovative, che per ricerche più consolidate che riuniscono ricercatori di enti diversi.
Conoscere meglio Sars-CoV-2, a partire dalla caratterizzazione delle sue varianti e dei meccanismi di diffusione e patogenicità fino all’individuazione di strategie innovative per la diagnosi, la prevenzione e la cura. E’ questo lo spirito del bando per il finanziamento di progetti di ricerca biennali, del valore di 4 milioni di euro (finanziati dal Ministero della Salute attraverso ISS), appena pubblicato nell’ambito del progetto “Rete Italiana per la sorveglianza virologica, il monitoraggio immunologico, la formazione e la ricerca in Preparazione alla gestione delle Emergenze Infettive – R.I.Pr.E.I.”. Al bando possono partecipare ricercatori che operano presso Università, Enti di Ricerca, Enti del Ssn e Sanità militare. Sono previsti finanziamenti sia per progetti pilota, monocentrici, dedicati a idee innovative, che per ricerche più consolidate che riuniscono ricercatori di enti diversi. La Malattia Emorragica Epizootica del Cervo (EHD), causata da un virus trasmesso dalla puntura di insetti del genere Culicoides, fu individuata per la prima volta nel 1955 durante un’epidemia che colpì gravemente una specie di cervi caratteristica del Nord America. In questi animali, dai quali ha preso il nome originario, la patologia può assumere caratteristiche molto gravi, fino a portare alla morte in una grande percentuale di casi. Ma gli anni successivi mostrarono come possano esserne colpite anche altre specie di ruminanti, sia selvatiche che domestiche come ovini e bovini. Mentre i primi, pur essendo portatori, non sviluppano segni clinici importanti, i bovini possono ammalarsi, con ripercussioni sulla produzione di latte e in generale sull’intero sistema di allevamento
La Malattia Emorragica Epizootica del Cervo (EHD), causata da un virus trasmesso dalla puntura di insetti del genere Culicoides, fu individuata per la prima volta nel 1955 durante un’epidemia che colpì gravemente una specie di cervi caratteristica del Nord America. In questi animali, dai quali ha preso il nome originario, la patologia può assumere caratteristiche molto gravi, fino a portare alla morte in una grande percentuale di casi. Ma gli anni successivi mostrarono come possano esserne colpite anche altre specie di ruminanti, sia selvatiche che domestiche come ovini e bovini. Mentre i primi, pur essendo portatori, non sviluppano segni clinici importanti, i bovini possono ammalarsi, con ripercussioni sulla produzione di latte e in generale sull’intero sistema di allevamento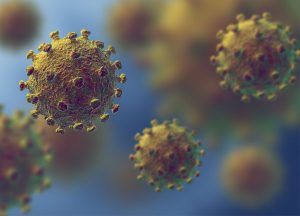 Alle misure draconiane finalizzate al contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 – il famigerato betacoronavirus responsabile della Covid-19 – ha fatto seguito l’adozione, da parte della Cina, di una politica diametralmente opposta.
Alle misure draconiane finalizzate al contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 – il famigerato betacoronavirus responsabile della Covid-19 – ha fatto seguito l’adozione, da parte della Cina, di una politica diametralmente opposta.