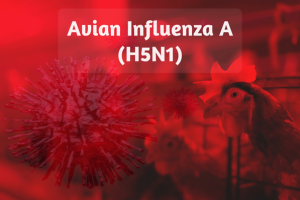 La crescente diffusione del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (highly pathogenic avian influenza virus, HPAI virus) AH5N1 nella popolazione bovina statunitense, unitamente al recente riscontro di materiale genetico virale nel latte bovino non pastorizzato (il virus risulterebbe comunque sensibile nei confronti delle temperature utilizzate nel processo di pastorizzazione), rappresentano per la Comunità Scientifica motivi di fondato allarme rispetto alla capacità dell’agente patogeno di adattarsi progressivamente alla nostra specie dando vita, in tal modo, ad una preoccupante catena di contagi interumani. Se e’ vero com’e’ vero, infatti, che a far tempo dall’inizio del 2003 a tutt’oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe registrato quasi 900 casi d’infezione da virus AH5N1 nell’uomo in 23 Paesi, con un allarmante tasso di mortalità pari al 52%, e’ altrettanto vero che non e’ stato finora segnalato alcun caso di trasmissione interumana.
La crescente diffusione del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (highly pathogenic avian influenza virus, HPAI virus) AH5N1 nella popolazione bovina statunitense, unitamente al recente riscontro di materiale genetico virale nel latte bovino non pastorizzato (il virus risulterebbe comunque sensibile nei confronti delle temperature utilizzate nel processo di pastorizzazione), rappresentano per la Comunità Scientifica motivi di fondato allarme rispetto alla capacità dell’agente patogeno di adattarsi progressivamente alla nostra specie dando vita, in tal modo, ad una preoccupante catena di contagi interumani. Se e’ vero com’e’ vero, infatti, che a far tempo dall’inizio del 2003 a tutt’oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe registrato quasi 900 casi d’infezione da virus AH5N1 nell’uomo in 23 Paesi, con un allarmante tasso di mortalità pari al 52%, e’ altrettanto vero che non e’ stato finora segnalato alcun caso di trasmissione interumana.
Ciò non significa, ovviamente, che una siffatta evenienza non si possa prima o poi verificare, vista e considerata la straordinaria capacità dei virus influenzali di mutare il proprio make-up genomico ed antigenico (c.d. “genome shift” e “antigenic drift“) attraverso i meccanismi/fenomeni di ricombinazione e di riassortimento genetico che notoriamente li contraddistinguono.
A tal proposito, mentre ci si interroga sull’origine di un recente caso d’infezione umana da virus AH5N1 in Texas, che potrebbe essere stato acquisito attraverso il contatto con un bovino infetto, preoccupa non poco la documentata trasmissione dell’agente virale dai volatili domestici agli uccelli selvatici e, da questi ultimi, a numerose specie di mammiferi domestici e selvatici, ivi compresi i mammiferi marini, con drammatici episodi di mortalità collettiva che hanno interessato i leoni marini lungo le coste di Perù, Argentina e Cile, unitamente a singoli casi d’infezione ad esito fatale che hanno interessato la cetofauna (focene e tursiopi) residente lungo le coste della Svezia e della Florida.
Di particolare rilievo appare, in un contesto caratterizzato da un crescente quanto allarmante ampliamento dello “spettro d’ospite” del virus a specie animali anche filogeneticamente distanti le une dalle altre, la recente segnalazione dell’infezione anche in un esemplare di orso polare (Ursus maritimus) in Alaska, con tutte le gravi implicazioni che ciò potrebbe comportare ai fini della conservazione di una specie la cui sopravvivenza in natura sarebbe già seriamente minacciata dal progressivo scioglimento dei ghiacci causato dal riscaldamento globale.
Degni di nota risultano, altresì, lo spiccato neurotropismo e la rilevante neuropatogenicità’ del virus AH5N1, caratteristiche inequivocabilmente comprovate dai gravi ed estesi quadri anatomo-istopatologici di meningo-encefalite riscontrati sia nei volatili sia nei mammiferi domestici (gatto) e selvatici (leone marino, focena, tursiope), quadri lesivi che il virus potrebbe continuare a produrre anche nella nostra specie, ove lo stesso dovesse mutare di quel tanto che gli basti ad avviare un’efficiente catena di trasmissione interumana.
Morale della favola, e’ assolutamente necessario e imprescindibile mantenere alta la guardia attraverso una capillare e diffusa attività di sorveglianza eco-epidemiologica su tutti i casi di malattia “simil-influenzale” umana, con particolare riferimento a quelli insorti in individui che abbiano avuto contatti recenti e/o reiterati con animali suscettibili nei confronti dell’infezione.
A ciò dovrebbe necessariamente associarsi, in una sana ottica di collaborazione intersettoriale e nel più completo rispetto di un approccio multidisciplinare e del concetto/principio della “One Health” – la salute unica di uomo, animali ed ambiente -, un’altrettanto capillare e diffusa attività di sorveglianza eco-epidemiologica, svolta in primis ad opera dei Servizi Veterinari nonché degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (presso i quali, è bene ricordarlo, sono attivi da anni “Centri di Referenza Nazionali” appositamente istituiti “ad hoc” per la lotta nei confronti delle malattie infettive animali e delle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo), su tutte le specie animali, domestiche e selvatiche, ritenute suscettibili all’infezione da virus AH5N1 e, più in generale, ai virus influenzali.
Teniamo sempre e comunque ben presente, al riguardo, che almeno i due terzi delle “malattie infettive emergenti” traggono la propria origine da un serbatoio animale, comprovato o presunto che esso sia, regola alla quale non avrebbe fatto eccezione neppure SARS-CoV-2, il famigerato betacoronavirus responsabile della COVID-19!
E, per favore, facciamo del nostro meglio, tutti insieme (visto che solo stando tutti insieme ci si salva, come a ogni piè sospinto Papa Francesco ci ricorda!), per non ripetere i drammatici errori che hanno contrassegnato e scandito l’evoluzione della pandemia da COVID-19, primo fra tutti la sconsiderata gestione “ospedalocentrica” della stessa e, fattispecie non meno rilevante, la mancata cooptazione dei Medici Veterinari nel “Comitato Tecnico-Scientifico per la Gestione della Pandemia” (popolarmente noto con l’acronimo “CTS”), come ho peraltro denunciato in una lettera a mia firma pubblicata nel 2021 sulla prestigiosa Rivista BMJ.
Quanto al CTS, poi, l’amaro in bocca rimane anche per il fatto che lo stesso e’ stato incomprensibilmente disciolto, mentre in previsione di future pandemie (non solo quella, qui trattata, da virus AH5N1, ma anche l’altra, “sic stantibus rebus” oltremodo plausibile e probabile, da uno o più “batteri super-resistenti agli antibiotici”) si sarebbe dovuto provvedere, di contro ed in ossequio al principio/concetto della “One Health”, a potenziarlo adeguatamente e a “rivisitarlo” nella propria composizione, includendovi almeno un Medico Veterinario.
Errare Humanum est Perseverare Autem Diabolicum!
Giovanni Di Guardo,
DVM, Dipl. ECVP,
Già Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo
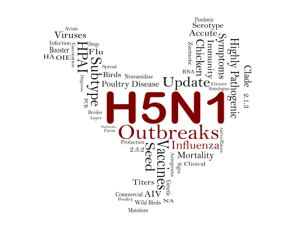 I Virus dell’Influenza Aviaria (VIA) sono oggetto di preoccupazione a causa del loro potenziale impatto sulla salute dei volatili domestici, della fauna selvatica e, se zoonosici, dell’uomo.
I Virus dell’Influenza Aviaria (VIA) sono oggetto di preoccupazione a causa del loro potenziale impatto sulla salute dei volatili domestici, della fauna selvatica e, se zoonosici, dell’uomo.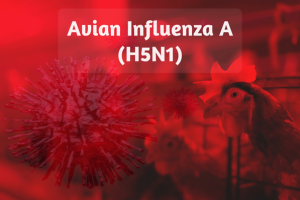 Le mucche hanno gli stessi recettori per i virus influenzali degli esseri umani e degli uccelli. Questo il risultato di uno studio in preprint, che aumenta la preoccupazione sulla situazione USA dove l’influenza aviaria si sta diffondendo rapidamente tra il bestiame.
Le mucche hanno gli stessi recettori per i virus influenzali degli esseri umani e degli uccelli. Questo il risultato di uno studio in preprint, che aumenta la preoccupazione sulla situazione USA dove l’influenza aviaria si sta diffondendo rapidamente tra il bestiame. Nelle attuali condizioni in Europa, la PSA (Peste Suina Africana) si trasmette da suino a suino – oltre che tramite carni infette o rifiuti di cucina – tramite contagio diretto (da animale ammalato ad animale sano) o indiretto (ad esempio, cioè, contagio mediato dall’uomo con scarpe od abiti contaminati). Attualmente è in corso un’ondata epidemica nei cinghiali in alcune zone della Pianura Padana, un territorio in cui mosche e zanzare sono largamente diffuse nei mesi estivi. Considerata questa situazione, c’è chi teme che questi insetti possano trasmettere la malattia, agendo da “vettori meccanici” del virus. Se venissero in contatto con un cinghiale ammalato o con una carcassa di cinghiale morto a causa della PSA, potrebbero avere la capacità di trasportare “passivamente” il virus; e così, spinte dal vento, introdurlo in aziende di suini domestici anche a chilometri di distanza.
Nelle attuali condizioni in Europa, la PSA (Peste Suina Africana) si trasmette da suino a suino – oltre che tramite carni infette o rifiuti di cucina – tramite contagio diretto (da animale ammalato ad animale sano) o indiretto (ad esempio, cioè, contagio mediato dall’uomo con scarpe od abiti contaminati). Attualmente è in corso un’ondata epidemica nei cinghiali in alcune zone della Pianura Padana, un territorio in cui mosche e zanzare sono largamente diffuse nei mesi estivi. Considerata questa situazione, c’è chi teme che questi insetti possano trasmettere la malattia, agendo da “vettori meccanici” del virus. Se venissero in contatto con un cinghiale ammalato o con una carcassa di cinghiale morto a causa della PSA, potrebbero avere la capacità di trasportare “passivamente” il virus; e così, spinte dal vento, introdurlo in aziende di suini domestici anche a chilometri di distanza. L’Oms Europa ha lanciato oggi congiuntamente la Rete paneuropea per il controllo delle malattie (Ndc) con l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa). L’Nds sarà ospitato dall’Ukhsa, con l’amministratore delegato dell’Ukhsa, Dame Jenny Harries, come presidente ad interim del gruppo direttivo.
L’Oms Europa ha lanciato oggi congiuntamente la Rete paneuropea per il controllo delle malattie (Ndc) con l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa). L’Nds sarà ospitato dall’Ukhsa, con l’amministratore delegato dell’Ukhsa, Dame Jenny Harries, come presidente ad interim del gruppo direttivo. Sono 27 i virus precedentemente sconosciuti, incluso un nuovo tipo di coronavirus, trovati nelle feci di
Sono 27 i virus precedentemente sconosciuti, incluso un nuovo tipo di coronavirus, trovati nelle feci di  Tracce di virus A H5N1 dell’influenza aviaria rilevate in alcuni campioni di latte pastorizzato di mucche provenienti da allevamenti negli Stati Uniti interessati dall’epidemia.
Tracce di virus A H5N1 dell’influenza aviaria rilevate in alcuni campioni di latte pastorizzato di mucche provenienti da allevamenti negli Stati Uniti interessati dall’epidemia. All’EFSA è stato richiesto di fornire una panoramica completa sulle opzioni efficaci di sorveglianza e le misure di riduzione del rischio di influenza aviaria. I nostri scienziati hanno esaminato tali misure e hanno valutato se le strategie di sorveglianza disponibili possano attestare l’assenza della malattia, consentendo così la movimentazione sicura del pollame e dei relativi prodotti.
All’EFSA è stato richiesto di fornire una panoramica completa sulle opzioni efficaci di sorveglianza e le misure di riduzione del rischio di influenza aviaria. I nostri scienziati hanno esaminato tali misure e hanno valutato se le strategie di sorveglianza disponibili possano attestare l’assenza della malattia, consentendo così la movimentazione sicura del pollame e dei relativi prodotti.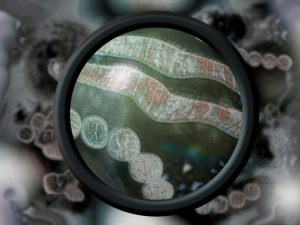 Negli USA la presenza di tanti allevamenti di bovini da latte di grandissime dimensioni con ampi parchi esterni rende più frequente e diretto il contatto tra avifauna selvatica e animali da allevamento. In passato, il virus aveva già dato origine a
Negli USA la presenza di tanti allevamenti di bovini da latte di grandissime dimensioni con ampi parchi esterni rende più frequente e diretto il contatto tra avifauna selvatica e animali da allevamento. In passato, il virus aveva già dato origine a