 Uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha riportato la presenza di alcune specie di flebotomi in aree della Pianura Padana dove non erano mai stati segnalati prima, e che possono trasmettere la leishmaniosi nei cani. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Parasites & Vectors.
Uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha riportato la presenza di alcune specie di flebotomi in aree della Pianura Padana dove non erano mai stati segnalati prima, e che possono trasmettere la leishmaniosi nei cani. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Parasites & Vectors.
Identikit dei flebotomi
I flebotomi o ‘pappataci’ sono piccoli ditteri ematofagi, vettori di diversi patogeni, tra i quali i più noti sono i protozoi del genere Leishmania e i virus del genere Phlebovirus. L’insetto adulto ha dimensioni ridotte (2-4 mm di lunghezza), è di color sabbia e ha il corpo e le ali ricoperti da una fitta peluria, grazie alla quale è in grado compiere un volo silenzioso e di nutrirsi senza emettere alcun rumore (da cui il nome ‘pappatacio’: “mangia e taci”).
Uno studio condotto da ricercatori dell’IZSVe ha riportato la presenza di alcune specie di flebotomi in aree della Pianura Padana dove non erano mai stati segnalati prima. Dal 2017 al 2019 sono stati catturati più di 300 esemplari grazie alle trappole utilizzate per la sorveglianza entomologica della West Nile Disease. Di notevole interesse il ritrovamento per la prima volta in Veneto e Friuli Venezia Giulia della specie Phlebotomus perfiliewi (vettore di Leishmania infantum e Toscana virus), specie che aveva il suo limite di distribuzione al Nord Italia sull’Appennino emiliano.
In Italia sono presenti otto specie e le più comuni sono P. papatasi, P. perniciosus e P. perfiliewi. I flebotomi sono molto comuni nelle aree del Centro e Sud Italia, mentre sono meno abbondanti nelle regioni settentrionali; qui sono confinate ad aree collinari e pedemontane, caratterizzate da un’altitudine compresa tra 100 e 800 metri, vegetazione abbondante e clima mite.
Espansione verso nord e in Pianura Padana
In studi sulla distribuzione di questi vettori condotti in passato era spesso riportato che “i flebotomi sono assenti in Pianura Padana”. Il motivo non è mai stato ben chiarito; probabilmente le condizioni climatiche e geologiche della pianura Padana non erano idonee allo sviluppo delle diverse specie di flebotomi.
Tuttavia, negli ultimi anni venivano segnalati sporadici ritrovamenti di alcuni esemplari di questo insetto. Partendo da questi “insoliti ritrovamenti” il Laboratorio di parassitologia, micologia ed entomologia sanitaria dell’IZSVe ha cominciato a raccogliere tutti gli esemplari di flebotomi che venivano catturati accidentalmente con le trappole utilizzate per la sorveglianza entomologica della West Nile Disease, quindi utilizzate per la cattura delle zanzare.
Dal 2017 al 2019 sono stati catturati più di 300 esemplari appartenenti alle specie Phlebotomus perniciosus, P. perfiliewi, P. mascittii e Sergentomyia minuta in aree di pianura, sia in ambienti rurali che peri-urbani. È stata osservata un’estensione dell’areale di distribuzione dei flebotomi, la cui presenza è stata segnalata in zone a maggiori latitudini e a diverse altitudini (addirittura anche a -2 metri), ambienti che si discostano da quelli tradizionalmente considerati idonei allo sviluppo di questi insetti. Di notevole interesse il ritrovamento per la prima volta in Veneto e Friuli Venezia Giulia della specie P. perfiliewi (vettore di Leishmania infantum e Toscana virus), specie che aveva il suo limite di distribuzione al Nord Italia sull’Appennino emiliano.
Sebbene in queste aree il numero di esemplari trovati è comunque limitato e inferiore a quello osservato negli ambienti tipicamente abitati dai flebotomi, la presenza di un vettore di patogeni in aree considerate ‘free’ è di grande rilevanza. Quindi, anche in Pianura Padana bisogna cominciare a porre attenzione nel proteggere i propri animali domestici (il cane principalmente) dalle punture di questi insetti, utilizzando prodotti repellenti registrati per la prevenzione della leishmaniosi.
Fonte: IZS delle Venezie
 L’identificazione della variante Omicron, recentemente avvenuta in Botswana e in Sudafrica—sebbene la stessa fosse già presente da diversi giorni nei Paesi Bassi e negli Usa —, ha reso ancor più esiguo il numero delle lettere dell’alfabeto greco non ancora
L’identificazione della variante Omicron, recentemente avvenuta in Botswana e in Sudafrica—sebbene la stessa fosse già presente da diversi giorni nei Paesi Bassi e negli Usa —, ha reso ancor più esiguo il numero delle lettere dell’alfabeto greco non ancora “
“
 ASAPS, da sempre attenta ai problemi di sicurezza stradale, fornisce alcuni dati del suo Osservatorio sugli incidenti con animali e consigli agli automobilisti ma anche agli enti proprietari strade.
ASAPS, da sempre attenta ai problemi di sicurezza stradale, fornisce alcuni dati del suo Osservatorio sugli incidenti con animali e consigli agli automobilisti ma anche agli enti proprietari strade.
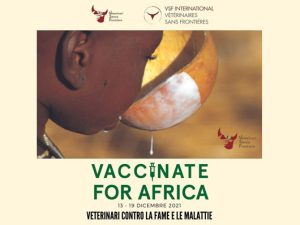 gna VACCINATE FOR AFRICA (V4A) è una raccolta fondi internazionale organizzata da VSF International. Si tratta di una campagna internazionale congiunta, realizzata in 9 Paesi del Network e che coinvolge le cliniche veterinarie a sostegno degli allevatori africani.
gna VACCINATE FOR AFRICA (V4A) è una raccolta fondi internazionale organizzata da VSF International. Si tratta di una campagna internazionale congiunta, realizzata in 9 Paesi del Network e che coinvolge le cliniche veterinarie a sostegno degli allevatori africani. Rafforzare i piani di prevenzione con un approccio globale tra salute umana, animale e ambientale per fronteggiare possibili future pandemie. E’ questo uno degli obiettivi primari del Policy Brief
Rafforzare i piani di prevenzione con un approccio globale tra salute umana, animale e ambientale per fronteggiare possibili future pandemie. E’ questo uno degli obiettivi primari del Policy Brief  La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha adottato una delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo secondo la quale:
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha adottato una delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo secondo la quale: Uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha riportato la presenza di alcune specie di flebotomi in aree della Pianura Padana dove non erano mai stati segnalati prima, e che possono trasmettere la
Uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha riportato la presenza di alcune specie di flebotomi in aree della Pianura Padana dove non erano mai stati segnalati prima, e che possono trasmettere la  A seguito di una richiesta della Commissione europea, è stato chiesto al gruppo di esperti scientifici dell’Aurità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sulla nutrizione, i nuovi alimenti e gli allergeni alimentari (NDA) di esprimere un parere sulla sicurezza delle formulazioni congelate ed essiccate della locusta migratoria (Locusta migratoria) come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.
A seguito di una richiesta della Commissione europea, è stato chiesto al gruppo di esperti scientifici dell’Aurità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sulla nutrizione, i nuovi alimenti e gli allergeni alimentari (NDA) di esprimere un parere sulla sicurezza delle formulazioni congelate ed essiccate della locusta migratoria (Locusta migratoria) come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.