Nuovi anticorpi monoclonali per l’identificazione della malattia emorragica epizootica del cervo
 Anticorpi monoclonali, sviluppati in IZS, permetteranno una più efficiente diagnosi di una malattia virale che colpisce prevalentemente i cervi, ma che può attaccare anche i bovini danneggiando la produzione di latte
Anticorpi monoclonali, sviluppati in IZS, permetteranno una più efficiente diagnosi di una malattia virale che colpisce prevalentemente i cervi, ma che può attaccare anche i bovini danneggiando la produzione di latte
La Malattia Emorragica Epizootica (EHD acronimo della malattia in lingua inglese), è una patologia virale identificata originariamente in alcune specie di cervi nel Nord America. Negli ultimi anni la malattia è stata registrata nei paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo. Una sua introduzione in Europa rappresenta pertanto un pericolo che richiede metodi di identificazione e sorveglianza rapidi ed efficienti. Ad oggi non sono stati ancora registrati casi nelle nazioni europee e quindi la malattia può dirsi esotica.
Per assolvere ad uno dei compiti istituzionali in qualità di Centro di Referenza per le Malattie Esotiche (CESME), i ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo hanno avviato una ricerca per lo sviluppo di un metodo diagnostico, i cui risultati preliminari sono stati pubblicati sulla rivista Monoclonal antibodies in Immunodiagnosis and Immunotherapy. I ricercatori hanno infatti prodotto anticorpi monoclonali capaci di riconoscere una proteina specifica del virus responsabile della patologia (EDHV). In questo modo sarà possibile realizzare test di laboratorio affidabili, capaci di portare ad una rapida identificazione della sua eventuale presenza in animali selvatici o da allevamento.
“La Malattia Emorragica Epizootica – spiega Mirella Luciani, del reparto di Immunologia e sierologia, co-autore della pubblicazione scientifica – non costituisce alcun pericolo per l’uomo. Colpisce soprattutto alcune specie di cervi, nei quali può essere particolarmente grave, con tassi di mortalità che possono arrivare fino al 90% per i cervi dalla coda bianca. Occasionalmente, però, può rappresentare un problema anche per i bovini, nei quali la sintomatologia è molto più lieve e la mortalità molto rara, ma in questi casi ci può essere un rilevante calo della produzione di latte con conseguenti danni economici”.
Il virus EDHV viene trasmesso attraverso la puntura di insetti del genere Culicoides, gli stessi che possono trasmettere altri due virus: la bluetongue, che colpisce prevalentemente gli ovini, e la peste equina, che colpisce prevalentemente gli equini. “Questi insetti – continua Luciani – sono presenti in Europa. A loro si devono, ad esempio, i focolai di bluetongue che in anni passati hanno colpito gli allevamenti di pecore in Italia, soprattutto in Sardegna. Quindi ci troviamo di fronte allo stesso ciclo infettivo e alla stessa nicchia ecologica. Significa che l’introduzione in Europa del virus della Malattia Emorragica Epizootica del Cervo è una possibilità concreta. Per questo motivo abbiamo sviluppato un pannello di anticorpi monoclonali che potranno rappresentare un valido supporto per la diagnosi precoce della malattia”.
Fonte: IZS Teramo
 L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato, nell’ambito dei Rapporti ISTISAN, il rapporto “Sorveglianza delle zanzare in Italia” a cura di Marco Di Luca del Dipartimento Malattie Infettive del ISS.
L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato, nell’ambito dei Rapporti ISTISAN, il rapporto “Sorveglianza delle zanzare in Italia” a cura di Marco Di Luca del Dipartimento Malattie Infettive del ISS. Le nitrosammine (o più formalmente N-Nitrosammine) sono composti chimici che possono formarsi negli alimenti a seguito della preparazione e trasformazione di questi ultimi. Tali sostanze sono state rilevate in svariati tipi di prodotti alimentari, quali prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura, pesce trasformato, cacao, birra e altre bevande alcoliche. Le nitrosammine possono anche essere presenti in diversi altri alimenti, come la carne cotta, gli ortaggi trasformati, i cereali, i prodotti lattiero-caseari oppure in alimenti fermentati, sottaceto e speziati. Alcune nitrosammine sono genotossiche (possono danneggiare il DNA) e cancerogene (possono causare il cancro). Il progetto di parere dell’EFSA valuta i rischi per la salute pubblica correlati alla presenza di nitrosammine negli alimenti.
Le nitrosammine (o più formalmente N-Nitrosammine) sono composti chimici che possono formarsi negli alimenti a seguito della preparazione e trasformazione di questi ultimi. Tali sostanze sono state rilevate in svariati tipi di prodotti alimentari, quali prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura, pesce trasformato, cacao, birra e altre bevande alcoliche. Le nitrosammine possono anche essere presenti in diversi altri alimenti, come la carne cotta, gli ortaggi trasformati, i cereali, i prodotti lattiero-caseari oppure in alimenti fermentati, sottaceto e speziati. Alcune nitrosammine sono genotossiche (possono danneggiare il DNA) e cancerogene (possono causare il cancro). Il progetto di parere dell’EFSA valuta i rischi per la salute pubblica correlati alla presenza di nitrosammine negli alimenti. Gli
Gli  L’articolo è stato pubblicato sulla rivista ‘The Lancet Planetary Health’, fra gli autori anche due ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), per gli ambiti di rabbia e malattie delle api.
L’articolo è stato pubblicato sulla rivista ‘The Lancet Planetary Health’, fra gli autori anche due ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), per gli ambiti di rabbia e malattie delle api. Il 19 settembre 2022 i servizi veterinari della regione Junta in Andalusia, Spagna, hanno notificato al WOAH un focolaio di vaiolo ovino e caprino in un allevamento ovino da riproduzione situato nel comune di Benamaurel, nella provincia di Granada.
Il 19 settembre 2022 i servizi veterinari della regione Junta in Andalusia, Spagna, hanno notificato al WOAH un focolaio di vaiolo ovino e caprino in un allevamento ovino da riproduzione situato nel comune di Benamaurel, nella provincia di Granada. A dispetto del fatto che la malattia di Alzheimer rappresenta la più comune forma di demenza a livello globale, i modelli animali finora caratterizzati non sarebbero in grado di ricapitolarne in maniera adeguata l’intero spettro delle peculiari lesioni osservate in ambito cerebrale, ovverosia i depositi di ß-amiloide (Aß) e gli aggregati neurofibrillari di proteina tau (1).
A dispetto del fatto che la malattia di Alzheimer rappresenta la più comune forma di demenza a livello globale, i modelli animali finora caratterizzati non sarebbero in grado di ricapitolarne in maniera adeguata l’intero spettro delle peculiari lesioni osservate in ambito cerebrale, ovverosia i depositi di ß-amiloide (Aß) e gli aggregati neurofibrillari di proteina tau (1).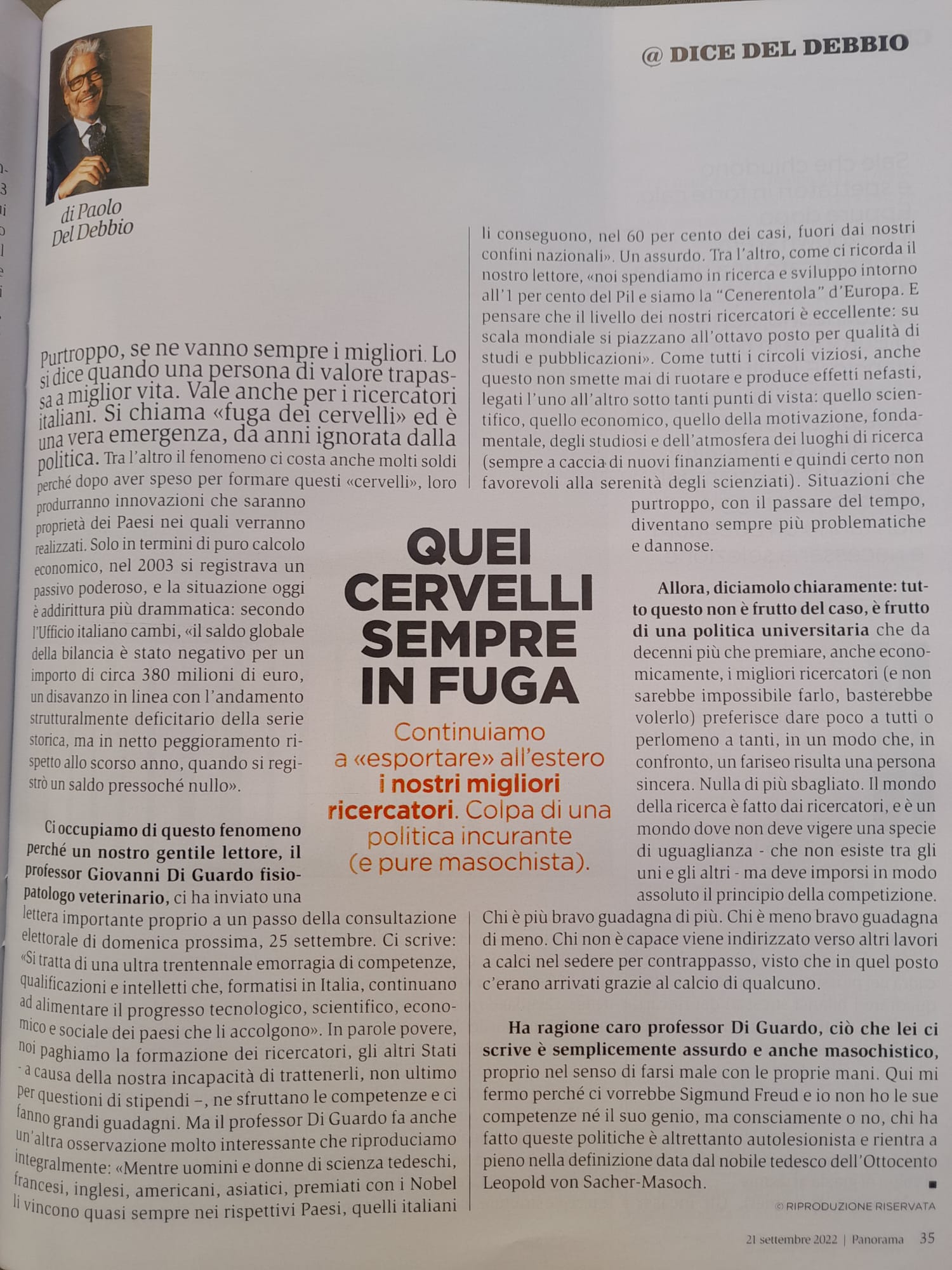
 Una Sola Salute, accreditato un nuovo laboratorio IZSLER per indagini virologiche e batteriologiche
Una Sola Salute, accreditato un nuovo laboratorio IZSLER per indagini virologiche e batteriologiche SARS CoV-2 negli animali, un sito per navigare in tutti gli eventi segnalati.
SARS CoV-2 negli animali, un sito per navigare in tutti gli eventi segnalati.