Apicoltura. Il questionario Coloss 2022/2023 sulla perdita di colonie
 Anche quest’anno l’associazione COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes, www.coloss.org) ha predisposto il questionario con cui raccogliere informazioni sulle perdite di colonie di api. Gli Stati europei e non solo che partecipano all’indagine somministrano annualmente agli apicoltori il questionario, standardizzato e uguale per tutti gli Stati, in modo da poter comparare a livello internazionale i dati raccolti e quindi comprendere meglio i fattori di rischio implicati nella perdita di colonie.
Anche quest’anno l’associazione COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes, www.coloss.org) ha predisposto il questionario con cui raccogliere informazioni sulle perdite di colonie di api. Gli Stati europei e non solo che partecipano all’indagine somministrano annualmente agli apicoltori il questionario, standardizzato e uguale per tutti gli Stati, in modo da poter comparare a livello internazionale i dati raccolti e quindi comprendere meglio i fattori di rischio implicati nella perdita di colonie.
Si chiede la collaborazione degli apicoltori, delle loro associazioni, dei veterinari e delle istituzioni coinvolte nel settore dell’apicoltura per una diffusione capillare di questa iniziativa, affinché anche l’Italia contribuisca in modo significativo a questo studio.
Compilazione del questionario
Il questionario è compilabile online, in italiano e in tedesco, dal seguente link:
Questionario COLOSS – Versione italiana » Questionario COLOSS – Versione tedesca »Alcune domande, contrassegnate da un asterisco rosso, sono particolarmente importanti per il questionario ed è obbligatorio rispondere. Altre domande (senza asterisco) sono facoltative, ma vi chiediamo di rispondere anche a queste per poterle confrontare con le risposte dei questionari raccolti negli altri stati.
È possibile salvare le risposte inserite e riprendere la compilazione in un secondo momento seguendo le istruzioni riportate.
Istruzioni per il salvataggio del questionario (in italiano) >
Istruzioni per il salvataggio del questionario (in tedesco) >
Per supporto tecnico nella compilazione del questionario:
tel. 049 8084265
Scadenze
Affinché i dati raccolti siano analizzati ed inclusi nell’indagine europea 2022-2023, è necessario compilare il questionario entro e non oltre il 15 giugno 2023 e rispondere a tutte le domande contrassegnate con un asterisco rosso. I dati raccolti saranno trasmessi, in un’unica soluzione, ai coordinatori internazionali del monitoraggio per la successiva analisi ed elaborazione.
Controllo della coerenza dei dati
Al fine di verificare la coerenza e validità dei dati inseriti, si evidenziano alcuni punti:
- Il numero di colonie ad inizio inverno non deve mancare e deve essere maggiori di zero
- Il numero delle colonie perse non deve mancare e deve essere maggiore o uguale a zero
- Il numero delle colonie morte, più quello delle colonie perse a causa di problemi con la regina, più quello delle colonie perse a causa di calamità naturali non deve essere maggiore del numero delle colonie all’inizio dell’inverno
- Gli apicoltori con 1 apiario non possono avere le loro colonie a più di 15 km di distanza l’una dall’altra, ecc.
- Il numero di colonie svernate che hanno avuto una nuova regina [nell’anno precedente] non può essere maggiore del numero di colonie svernate!
Fonte: IZS Venezie
 Un pesce istrice Chilomycterus reticulatus, conosciuto anche come pesce porcospino punteggiato, è l’esemplare di circa 60 cm spiaggiato a Santa Marinella e segnalato da un pescatore grazie alla campagna “
Un pesce istrice Chilomycterus reticulatus, conosciuto anche come pesce porcospino punteggiato, è l’esemplare di circa 60 cm spiaggiato a Santa Marinella e segnalato da un pescatore grazie alla campagna “ Mentre continua a suscitare grande scalpore l’inchiesta giudiziaria sull’impressionante numero di decessi avvenuti in Val Seriana durante le prime fasi della pandemia da SARS-CoV-2, credo sia utile fare alcune precisazioni.
Mentre continua a suscitare grande scalpore l’inchiesta giudiziaria sull’impressionante numero di decessi avvenuti in Val Seriana durante le prime fasi della pandemia da SARS-CoV-2, credo sia utile fare alcune precisazioni. Continua a evolversi in Europa e a livello mondiale la situazione dell’influenza aviaria: segnalati nuovi focolai nei volatili e infezioni occasionali nei mammiferi. Sporadiche infezioni nell’uomo sono state segnalate in Paesi extra-UE, ma il rischio per la popolazione UE rimane basso. Sono queste alcune delle risultanze evidenziate nell’
Continua a evolversi in Europa e a livello mondiale la situazione dell’influenza aviaria: segnalati nuovi focolai nei volatili e infezioni occasionali nei mammiferi. Sporadiche infezioni nell’uomo sono state segnalate in Paesi extra-UE, ma il rischio per la popolazione UE rimane basso. Sono queste alcune delle risultanze evidenziate nell’ A tre anni dalla sua esplosione, la pandemia sembra essere finalmente avviata verso la sua coda finale. Tuttavia, se quello che sta accadendo nell’uomo suggerisce un cauto ottimismo, gli esperti invitano a non perdere di vista quello che sta succedendo negli animali, dove il virus Sars-CoV-2 potrebbe trovare nuovi serbatoi e da lì tornare, magari in forma mutata, all’uomo.
A tre anni dalla sua esplosione, la pandemia sembra essere finalmente avviata verso la sua coda finale. Tuttavia, se quello che sta accadendo nell’uomo suggerisce un cauto ottimismo, gli esperti invitano a non perdere di vista quello che sta succedendo negli animali, dove il virus Sars-CoV-2 potrebbe trovare nuovi serbatoi e da lì tornare, magari in forma mutata, all’uomo. Anche gli Oceani avranno le aree protette, è il risultato dell’accordo storico all’Onu per il primo trattato internazionale a protezione dell’alto mare, quello che a oltre 200 miglia nautiche dalle coste esula dalle giurisdizioni nazionali e rappresenta i due terzi degli oceani, che rappresentano ecosistemi fondamentali per l’umanità.
Anche gli Oceani avranno le aree protette, è il risultato dell’accordo storico all’Onu per il primo trattato internazionale a protezione dell’alto mare, quello che a oltre 200 miglia nautiche dalle coste esula dalle giurisdizioni nazionali e rappresenta i due terzi degli oceani, che rappresentano ecosistemi fondamentali per l’umanità.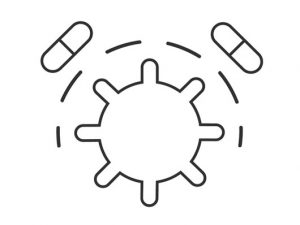 La resistenza dei batteri Salmonella e Campylobacter ad antimicrobici di uso comune viene osservata nell’uomo e negli animali di frequente, si rende noto in un rapporto pubblicato oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La resistenza simultanea ad antimicrobici di importanza critica per l’uomo è stata però rilevata generalmente a livelli bassi, eccezion fatta per alcuni tipi di Salmonella e Campylobacter coli in parecchi Paesi.
La resistenza dei batteri Salmonella e Campylobacter ad antimicrobici di uso comune viene osservata nell’uomo e negli animali di frequente, si rende noto in un rapporto pubblicato oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La resistenza simultanea ad antimicrobici di importanza critica per l’uomo è stata però rilevata generalmente a livelli bassi, eccezion fatta per alcuni tipi di Salmonella e Campylobacter coli in parecchi Paesi. L’Ibis eremita (Geronticus eremita) è uno degli uccelli più rari al mondo; un tempo era diffuso in tutto il Medio Oriente, in Africa settentrionale ed Europa meridionale e centrale, ma da oltre 400 anni risulta scomparso dall’Europa e ne è rimasta una sola popolazione riproduttiva in Marocco, Algeria, Turchia e Siria.
L’Ibis eremita (Geronticus eremita) è uno degli uccelli più rari al mondo; un tempo era diffuso in tutto il Medio Oriente, in Africa settentrionale ed Europa meridionale e centrale, ma da oltre 400 anni risulta scomparso dall’Europa e ne è rimasta una sola popolazione riproduttiva in Marocco, Algeria, Turchia e Siria. Il Rotavirus gruppo A è una delle cause più comuni di diarrea del puledro. A partire da febbraio 2021, negli USA c’è stato un aumento della frequenza di casi gravi di diarrea emorragica nei puledri neonati. Le indagini hanno identificato come responsabile un nuovo gruppo di Rotavirus appartenente al gruppo B, molto simile ai rotavirus dello stesso gruppo precedentemente trovati nei ruminanti.
Il Rotavirus gruppo A è una delle cause più comuni di diarrea del puledro. A partire da febbraio 2021, negli USA c’è stato un aumento della frequenza di casi gravi di diarrea emorragica nei puledri neonati. Le indagini hanno identificato come responsabile un nuovo gruppo di Rotavirus appartenente al gruppo B, molto simile ai rotavirus dello stesso gruppo precedentemente trovati nei ruminanti.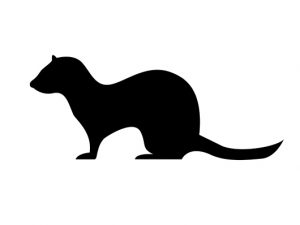 L’Ecdc, Centro europeo per il controllo delle malattie e L’Efsa, Agenzia europea per la sicurezza alimentare hanno pubblicato il Risk Assestment “
L’Ecdc, Centro europeo per il controllo delle malattie e L’Efsa, Agenzia europea per la sicurezza alimentare hanno pubblicato il Risk Assestment “