 Una nuova piattaforma, unica in Europa, per verificare le azioni attuate nella lotta all’antibioticoresistenza. Regioni e Aziende Sanitarie Locali potranno scambiarsi le esperienze, misurare e migliorare le performance
Una nuova piattaforma, unica in Europa, per verificare le azioni attuate nella lotta all’antibioticoresistenza. Regioni e Aziende Sanitarie Locali potranno scambiarsi le esperienze, misurare e migliorare le performance
Al via SPiNCAR, la piattaforma messa a punto e gestita dall’Istituto Superiore di Sanità per il monitoraggio delle azioni di contrasto all’antimicrobico resistenza destinata a Regioni e Aziende Sanitarie. Il sistema, realizzato all’interno dei progetti CCM 2018 del Ministero della Salute, definisce standard e indicatori omogenei per tutte le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, permettendo a Regioni ed Aziende Sanitarie di confrontare tra loro lo stato di avanzamento ed applicazione del Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (Pncar), e di definire le priorità d’azione. Nella prima fase ogni ente coinvolto, regionale o locale, dovrà compilare delle checklist di tutte le azioni attuate fino al 2022, in base alle quali verrà definito lo stato dell’arte.
“Si tratta del primo monitoraggio di questo tipo che viene effettuato in Italia, dopo la messa a punto dello strumento, che non ha eguali nel resto d’Europa – sottolinea il Presidente dell’ISS Silvio Brusaferro -. I risultati della rilevazione saranno utili a tutti i livelli per comprendere lo stato di attuazione delle politiche di contrasto all’antimicrobico resistenza e individuare le principali aree di criticità”.
Che cos’è SPiNCAR
Di fatto lo strumento è una check-list di standard e criteri con la produzione di grafici sui risultati raggiunti che si possono confrontare alla media nazionale. Gli standard, i criteri e gli indicatori utilizzati sono stati selezionati mediante una revisione delle evidenze scientifiche e delle buone pratiche disponibili a livello nazionale e internazionale, in ambito umano e veterinario, relativi a sette diverse aree tematiche: governance, sorveglianza e monitoraggio, uso appropriato degli antibiotici, controllo delle infezioni controllate all’assistenza, formazione, alleanza per il contrasto all’antimicrobico-resistenza, valutazione dell’impatto e implementazione del programma. La trattazione congiunta degli aspetti relativi all’ambito umano e veterinario ha lo scopo di favorire l’integrazione tra discipline e settori e promuovere un approccio comune nel pieno rispetto dei principi One Health. Lo strumento è disponibile tramite un’apposita piattaforma web ad accesso riservato per la rilevazione, per l’anno 2022 è iniziata nel mese di luglio e avrà la durata di un trimestre. Tutte le strutture del Sistema Sanitario Nazionale (Regioni e Province Autonome, Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere) sono state invitate a partecipare su base volontaria. Spincar è stato realizzato all’interno dei progetti CCM 2018 del Ministero della Salute con il coordinamento dell’Università di Udine e con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, delle Università di Torino, Catania e Milano e dell’Aop di Catania. Lo strumento è ora messo a disposizione dall’Istituto Superiore di Sanità in accordo con il Ministero della Salute.
L’AMR
Il fenomeno dell’antimicrobico-resistenza (AMR), cioè la capacità di un microrganismo di resistere all’attività di un farmaco antimicrobico, è considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una delle sfide più importanti nell’ambito di sanità pubblica a livello mondiale nel prossimo futuro. L’Italia si colloca ai primi posti tra i Paesi dell’Unione Europea sia per consumi di antimicrobici, spesso impropri, sia per i livelli di resistenza antimicrobica, con significative ricadute in termini clinici ed economici come riportato dai rapporti ECDC.
Sebbene la trasformazione dei ceppi batterici in organismi resistenti sia un meccanismo evolutivo naturale, l’uso improprio di antimicrobici a livello ospedaliero e territoriale, in campo veterinario e agricolo aumenta la pressione selettiva favorendo l’emergere, la moltiplicazione e la diffusione dei ceppi resistenti.
Si tratta, dunque, di un problema strutturato su molteplici livelli che impone l’impiego di strategie di intervento interdisciplinari e intersettoriali, per contrastare le quali, il Ministero della Salute ha preparato il Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020, prorogato al 2021, e il successivo aggiornamento per il triennio 2022-2025 indicando le azioni e gli obiettivi da perseguire nel contrasto a questa minaccia.
Il protocollo per la raccolta dati e l’accesso per gli utenti autorizzati per l’immissione dei dati sono disponibili sul sito https://spincar.iss.it
Fonte: ISS
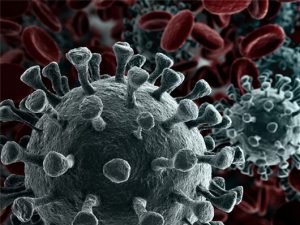 Per chi segue la continua evoluzione di SARS-CoV-2, è stato un Ferragosto di lavoro e scambio frenetico di informazioni. A provocare tanto scompiglio è stata la comparsa di una nuova variante molto mutata rispetto a quelle che coesistono da mesi. Dopo l’enorme ondata di Omicron che provocò un numero record di casi a cavallo tra il 2021 e il 2022, nessun altro virus mutante o ricombinante è finora riuscito a spazzare via tutti gli altri. Con alti e bassi, convivono decine di versioni diverse del coronavirus pandemico, in quella che è stata chiamata una “zuppa di varianti”. Ora però qualcuno sembra pronto a scommettere che siamo di fronte a una nuova svolta nella storia della pandemia.
Per chi segue la continua evoluzione di SARS-CoV-2, è stato un Ferragosto di lavoro e scambio frenetico di informazioni. A provocare tanto scompiglio è stata la comparsa di una nuova variante molto mutata rispetto a quelle che coesistono da mesi. Dopo l’enorme ondata di Omicron che provocò un numero record di casi a cavallo tra il 2021 e il 2022, nessun altro virus mutante o ricombinante è finora riuscito a spazzare via tutti gli altri. Con alti e bassi, convivono decine di versioni diverse del coronavirus pandemico, in quella che è stata chiamata una “zuppa di varianti”. Ora però qualcuno sembra pronto a scommettere che siamo di fronte a una nuova svolta nella storia della pandemia. Lo stress termico prolungato, connesso alla disidratazione e all’impossibilità di dissipare calore, può avere effetti drammatici sugli animali selvatici, in particolare sugli uccelli, fino a condurre alla morte. Per evitare questo esito infausto, basterebbe avere alcuni accorgimenti nella progettazione e costruzione delle strutture destinate ad ospitarli.
Lo stress termico prolungato, connesso alla disidratazione e all’impossibilità di dissipare calore, può avere effetti drammatici sugli animali selvatici, in particolare sugli uccelli, fino a condurre alla morte. Per evitare questo esito infausto, basterebbe avere alcuni accorgimenti nella progettazione e costruzione delle strutture destinate ad ospitarli.
 “Il granchio blu del Mar Rosso, morfologicamente ed ecologicamente simile al granchio blu Atlantico C. sapidus, ha già colonizzato, attraverso il Canale di Suez, i settori più orientali del Mediterraneo, con conseguenze inizialmente drammatiche per la pesca tunisina. Questa specie è oggi una delle risorse di pesca più importanti per la Tunisia, trasformata e commercializzata nei mercati esteri”, afferma Ernesto Azzurro, dirigente di ricerca del Cnr-Irbim. “Anche il granchio blu del Mar Rosso – come il granchio blu americano – trova il suo habitat ideale tra gli ambienti lagunari e il mare aperto e può sviluppare popolazioni con altissime abbondanze”.
“Il granchio blu del Mar Rosso, morfologicamente ed ecologicamente simile al granchio blu Atlantico C. sapidus, ha già colonizzato, attraverso il Canale di Suez, i settori più orientali del Mediterraneo, con conseguenze inizialmente drammatiche per la pesca tunisina. Questa specie è oggi una delle risorse di pesca più importanti per la Tunisia, trasformata e commercializzata nei mercati esteri”, afferma Ernesto Azzurro, dirigente di ricerca del Cnr-Irbim. “Anche il granchio blu del Mar Rosso – come il granchio blu americano – trova il suo habitat ideale tra gli ambienti lagunari e il mare aperto e può sviluppare popolazioni con altissime abbondanze”.
 Una nuova piattaforma, unica in Europa, per verificare le azioni attuate nella lotta all’antibioticoresistenza. Regioni e Aziende Sanitarie Locali potranno scambiarsi le esperienze, misurare e migliorare le performance
Una nuova piattaforma, unica in Europa, per verificare le azioni attuate nella lotta all’antibioticoresistenza. Regioni e Aziende Sanitarie Locali potranno scambiarsi le esperienze, misurare e migliorare le performance L’Ufficio 2 – Igiene degli alimenti ed esportazioni della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute ha diffuso una nota sulla pubblicazione delle Linee Guida per la valutazione del rischio per la gestione uniforme del monitoraggio delle biotossine marine nelle aree di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi a livello nazionale.
L’Ufficio 2 – Igiene degli alimenti ed esportazioni della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute ha diffuso una nota sulla pubblicazione delle Linee Guida per la valutazione del rischio per la gestione uniforme del monitoraggio delle biotossine marine nelle aree di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi a livello nazionale. A febbraio 2023 la sezione Sicurezza Alimentare del CNSA (Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare, ha emesso il documento tecnico “
A febbraio 2023 la sezione Sicurezza Alimentare del CNSA (Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare, ha emesso il documento tecnico “ Il 20 settembre 2022 è stato pubblicato il nuovo
Il 20 settembre 2022 è stato pubblicato il nuovo