Le sorprese (amare) non finiscono mai!
 Nella mia attuale veste di professore universitario in pensione dopo una gratificante carriera di docenza accademica ed una nutrita serie di convegni alle spalle, confesso di non aver mai partecipato, prima d’ora, ad un simposio internazionale i cui lavori non fossero aperti dai saluti delle Autorità locali.
Nella mia attuale veste di professore universitario in pensione dopo una gratificante carriera di docenza accademica ed una nutrita serie di convegni alle spalle, confesso di non aver mai partecipato, prima d’ora, ad un simposio internazionale i cui lavori non fossero aperti dai saluti delle Autorità locali.
Ecco i fatti: dal 10 al 12 Aprile si è svolta a Catania, presso il rinomato Centro Congressi “Le Ciminiere”, la 35.ma Conferenza Annuale della “European Cetacean Society” (“Società Europea di Cetologia”), che ha visto la partecipazione di circa 600 studiosi provenienti da ben 42 Paesi, 24 Europei e 18 extra-Europei.
Orbene, nonostante le locandine ed i manifesti congressuali recassero in bella mostra il logo del Municipio di Catania nonché quello della Regione Siciliana, non un singolo rappresentante di tali Istituzioni si è presentato alla cerimonia inaugurale per portare quantomeno un “doveroso” cenno di saluto!
Riporto tutto ciò con un sentimento misto di stupore e di amarezza, che mi deriva anche dall’avere origini catanesi, di cui vado oltremodo fiero e orgoglioso.
E’ particolarmente triste dover constatare, altresì, come un siffatto desolante accadimento non deponga a favore della quantomai auspicabile e benemerita sinergia di intenti, di strategie e di azioni fra la Comunità Scientifica, da un lato, e la Pubblica Amministrazione, dall’altro, ma che rischi di tradursi, al contrario, in un approfondimento del solco che, a dispetto del cambiamento climatico e delle altre drammatiche sfide che la contemporaneità ci pone di fronte, continua purtroppo a tenere le due componenti separate l’una dall’altra.
Errare Humanum est Perseverare Autem Diabolicum!
Giovanni Di Guardo,
DVM, Dipl. ECVP,
Già Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo
 All’EFSA è stato richiesto di fornire una panoramica completa sulle opzioni efficaci di sorveglianza e le misure di riduzione del rischio di influenza aviaria. I nostri scienziati hanno esaminato tali misure e hanno valutato se le strategie di sorveglianza disponibili possano attestare l’assenza della malattia, consentendo così la movimentazione sicura del pollame e dei relativi prodotti.
All’EFSA è stato richiesto di fornire una panoramica completa sulle opzioni efficaci di sorveglianza e le misure di riduzione del rischio di influenza aviaria. I nostri scienziati hanno esaminato tali misure e hanno valutato se le strategie di sorveglianza disponibili possano attestare l’assenza della malattia, consentendo così la movimentazione sicura del pollame e dei relativi prodotti.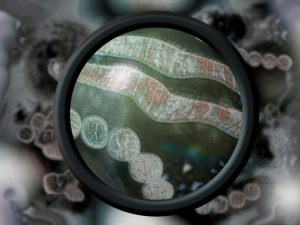 Negli USA la presenza di tanti allevamenti di bovini da latte di grandissime dimensioni con ampi parchi esterni rende più frequente e diretto il contatto tra avifauna selvatica e animali da allevamento. In passato, il virus aveva già dato origine a
Negli USA la presenza di tanti allevamenti di bovini da latte di grandissime dimensioni con ampi parchi esterni rende più frequente e diretto il contatto tra avifauna selvatica e animali da allevamento. In passato, il virus aveva già dato origine a  ll cinghiale (Sus scrofa) è una specie animale sociale originaria dell’Eurasia. Durante l’ultimo decennio, la popolazione di cinghiali in Estonia è stata gravemente colpita dal virus della peste suina africana (PSA/ ASFV), che ha colpito anche l’allevamento di suini domestici. Le potenziali vie di trasmissione della PSA rimangono poco chiare e sono attualmente oggetto di indagini approfondite. Questo studio pilota mirava a chiarire la frequenza e le caratteristiche dei contatti tra cinghiali vivi e le carcasse dei loro conspecifici, che potrebbero svolgere un ruolo nella trasmissione della PSA. Il contatto degli animali selvatici ed il comportamento del grufolare sulle carcasse di cinghiali è stato studiato utilizzando telecamere da trail in un ambiente sperimentale a Hiiumaa, nell’Estonia occidentale.
ll cinghiale (Sus scrofa) è una specie animale sociale originaria dell’Eurasia. Durante l’ultimo decennio, la popolazione di cinghiali in Estonia è stata gravemente colpita dal virus della peste suina africana (PSA/ ASFV), che ha colpito anche l’allevamento di suini domestici. Le potenziali vie di trasmissione della PSA rimangono poco chiare e sono attualmente oggetto di indagini approfondite. Questo studio pilota mirava a chiarire la frequenza e le caratteristiche dei contatti tra cinghiali vivi e le carcasse dei loro conspecifici, che potrebbero svolgere un ruolo nella trasmissione della PSA. Il contatto degli animali selvatici ed il comportamento del grufolare sulle carcasse di cinghiali è stato studiato utilizzando telecamere da trail in un ambiente sperimentale a Hiiumaa, nell’Estonia occidentale. Le recenti notizie di
Le recenti notizie di  La tubercolosi è una malattia , che prima dell’avvento degli antibiotici, ha portato a morte diversi uomini. Oggi non è più così grazie all’uso degli antibiotici, anche se esistono forme resistenti ai trattamenti d’elezione.
La tubercolosi è una malattia , che prima dell’avvento degli antibiotici, ha portato a morte diversi uomini. Oggi non è più così grazie all’uso degli antibiotici, anche se esistono forme resistenti ai trattamenti d’elezione. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Stoccolma ha scoperto che i Pfas vengono riemessi nell’aria dalle onde oceaniche con una frequenza maggiore rispetto a quanto si pensasse.
Un gruppo di ricercatori dell’Università di Stoccolma ha scoperto che i Pfas vengono riemessi nell’aria dalle onde oceaniche con una frequenza maggiore rispetto a quanto si pensasse. Il granchio blu atlantico (Callinectes sapidus) è una specie cosiddetta “aliena” per il territorio europeo, introdotta al di fuori del suo areale naturale di distribuzione (la costa occidentale dell’oceano Atlantico). La sua capacità di adattamento all’ambiente, l’elevata fecondità e capacità di dispersione, le grandi dimensioni e il comportamento aggressivo lo rendono una specie ad alto potenziale invasivo. Sebbene la sua presenza sia stata riportata nel Mediterraneo a partire dalla seconda metà del secolo scorso, questa specie ha provocato recentemente importanti impatti negativi ai
Il granchio blu atlantico (Callinectes sapidus) è una specie cosiddetta “aliena” per il territorio europeo, introdotta al di fuori del suo areale naturale di distribuzione (la costa occidentale dell’oceano Atlantico). La sua capacità di adattamento all’ambiente, l’elevata fecondità e capacità di dispersione, le grandi dimensioni e il comportamento aggressivo lo rendono una specie ad alto potenziale invasivo. Sebbene la sua presenza sia stata riportata nel Mediterraneo a partire dalla seconda metà del secolo scorso, questa specie ha provocato recentemente importanti impatti negativi ai  Nel novembre 2023,
Nel novembre 2023, Dal 1 gennaio all’8 aprile 2024, al sistema di sorveglianza nazionale delle arbovirosi risultano: 117 casi confermati di Dengue (tutti associati a viaggi all’estero, età mediana di 42 anni, 50% di sesso maschile e nessun decesso); 1 caso confermato di Zika Virus (associato a viaggio all’estero, nessun decesso); 3 casi confermati di Chikungunya (tutti associati a viaggi all’estero, età mediana di 46 anni, 67% di sesso maschile, nessun decesso); 1 caso confermato di infezione neuro-invasiva – TBE (autoctono, nessun decesso); nessun caso di Toscana Virus. Per maggiori informazioni sui dati consulta la
Dal 1 gennaio all’8 aprile 2024, al sistema di sorveglianza nazionale delle arbovirosi risultano: 117 casi confermati di Dengue (tutti associati a viaggi all’estero, età mediana di 42 anni, 50% di sesso maschile e nessun decesso); 1 caso confermato di Zika Virus (associato a viaggio all’estero, nessun decesso); 3 casi confermati di Chikungunya (tutti associati a viaggi all’estero, età mediana di 46 anni, 67% di sesso maschile, nessun decesso); 1 caso confermato di infezione neuro-invasiva – TBE (autoctono, nessun decesso); nessun caso di Toscana Virus. Per maggiori informazioni sui dati consulta la