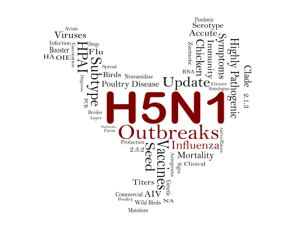 L’epidemia di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità verificatasi tra il 2021 e il 2022 nel nord est Italia è stata una delle più gravi di sempre, con il coinvolgimento di 317 allevamenti avicoli e oltre 14 milioni di animali. La maggior parte degli allevamenti colpiti dall’epidemia è localizzata in un’area considerata ad alta densità, dove viene allevato circa il 70% del pollame italiano. La diffusione dell’epidemia è stata estremamente rapida, coinvolgendo inizialmente la provincia di Verona per poi espandersi alle province e alle Regioni circostanti, con picchi di oltre 50 nuovi focolai a settimana.
L’epidemia di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità verificatasi tra il 2021 e il 2022 nel nord est Italia è stata una delle più gravi di sempre, con il coinvolgimento di 317 allevamenti avicoli e oltre 14 milioni di animali. La maggior parte degli allevamenti colpiti dall’epidemia è localizzata in un’area considerata ad alta densità, dove viene allevato circa il 70% del pollame italiano. La diffusione dell’epidemia è stata estremamente rapida, coinvolgendo inizialmente la provincia di Verona per poi espandersi alle province e alle Regioni circostanti, con picchi di oltre 50 nuovi focolai a settimana.
La grande velocità con cui l’epidemia si è diffusa sul territorio ha fatto emergere due ipotesi principali: 1) possibili fenomeni di contatto diretto tra allevamenti infetti e altre aziende avicole, oppure 2) la presenza di comuni fonti di infezione, che hanno determinato in breve tempo l’emergere di molteplici nuovi focolai.
Il Laboratorio epidemiologia e analisi del rischio in sanità pubblica ha analizzato la dinamica di diffusione dell’epidemia di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità verificatasi tra il 2021 e il 2022 nel nord est Italia. Per farlo è stata adottata la network analysis, una metodologia che permette di integrare efficacemente dati virologici (genomi di virus e cluster genetici virali) ed epidemiologici (caratteristiche degli allevamenti colpiti).
La sfida per il Laboratorio epidemiologia e analisi del rischio in sanità pubblica (SCS4) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) è stato di riuscire a spiegare la dinamica dell’epidemia valutando l’impatto di potenziali fattori di diffusione dell’infezione e utilizzando i dati raccolti durante i sopralluoghi negli allevamenti e le informazioni genetiche ottenute dalle analisi biomolecolari sui virus isolati da ciascun focolaio. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Pathogens.
Network analysis ed epidemia di aviaria 2021-2022
Per condurre questo tipo di analisi è stato scelto di sfruttare la network analysis, una metodologia che trova applicazione in diversi ambiti, tra cui le scienze economiche, sociali, psicologiche, biologiche, ecc. Questo potente strumento di analisi permette di studiare le caratteristiche e le relazioni tra gli oggetti esistenti all’interno di un network: i nodi rappresentano delle entità, gli oggetti, mentre le connessioni rappresentano una relazione esistente tra queste entità.
Nel contesto dell’epidemia 2021-2022, le analisi filogenetiche condotte dal Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle hanno rivelato l’esistenza di diversi cluster genetici virali che rafforzano l’ipotesi di una diffusione del virus tra gli allevamenti domestici. Le successive analisi virologiche si sono quindi concentrate a valutare il grado di similarità genetica dei virus sequenziati appartenenti allo stesso cluster.
Nello specifico, i genomi completi di 214 virus sono stati utilizzati per costruire il network filogenetico. In questo network, ogni nodo corrisponde ad un virus identificato in un singolo focolaio, mentre i link mettono in relazione nodi caratterizzati dalla massima similarità genetica. Il network filogenetico rappresenta la base dati di partenza dello studio, su cui è stata applicata la metodica di network analysis denominata Exponential Random Graph Model (ERGM). L’ERGM è un modello statistico capace di spiegare il motivo per cui esiste un link tra due nodi, sulla base di una serie di variabili epidemiologiche. Applicato ad un network filogenetico, l’ERGM mette in relazione le caratteristiche epidemiologiche degli allevamenti colpiti con quelle più strettamente genetiche dei virus trovati. Questo approccio ha quindi consentito di valutare l’impatto di tali variabili sulla possibilità di diffusione dell’infezione tra gli allevamenti.
Le variabili dei network di diffusione virale
Dalle analisi è emerso che solo alcune variabili hanno un effetto significativo nella definizione della struttura del network e, conseguentemente, nella possibile trasmissione della malattia. Tra queste, le più importanti sono risultate l’appartenenza degli allevamenti alla stessa filiera avicola, la durata dell’esposizione degli allevamenti a focolai attivi e la distanza geografica tra le aziende.
Dalle analisi è emerso che solo alcune variabili hanno un effetto significativo nella definizione della struttura del network e, conseguentemente, nella possibile trasmissione della malattia. Tra queste, le più importanti sono risultate l’appartenenza degli allevamenti alla stessa filiera avicola, la durata dell’esposizione degli allevamenti a focolai attivi e la distanza geografica tra le aziende, che suggeriscono importanti implicazioni dal punto di possibili strategie di controllo, gestione e prevenzione di future epidemie di Influenza aviaria sul nostro territorio.
Lo studio dell’epidemia mediante l’applicazione della network analysis, normalmente utilizzata nelle scienze sociali, si è rivelato non solo innovativo ma anche valido per integrare efficacemente i dati virologici ed epidemiologici. Infatti, in molta letteratura scientifica spesso gli aspetti virologici ed epidemiologici di un’epidemia vengono presentati in maniera disgiunta, mentre in questo caso i dati epidemiologici sono stati utilizzati proprio per ‘spiegare’ la struttura dei dati virologici.
Ulteriori sviluppi di questo approccio sono già in cantiere. Per esempio, l’informazione relativa all’evoluzione di un’epidemia nel corso del tempo può essere integrata tramite la creazione di network ‘temporalizzati’, capaci di rappresentare con un quadro più dettagliato le dinamiche di diffusione spazio-temporale delle infezioni; oppure lo studio di malattie che coinvolgono diverse popolazioni (come, per esempio, le malattie trasmesse da vettori) potrebbe essere fatto tramite analisi dei cosiddetti multi-layer network, che integrano un maggior livello di complessità legato alla presenza di più ‘strati’ di entità che interagiscono tra loro all’interno dello stesso sistema.
Il potenziale applicativo della network analysis potrebbe in futuro aiutare gli epidemiologi a comprendere meglio la complessità delle malattie circolanti sul nostro territorio e fornire un efficace strumento di controllo e prevenzione delle epidemie.
Fonte: IZS Venezie
 La diffusione delle Zoonosi è riconosciuta come causa predominante delle malattie infettive emergenti e come responsabile principale delle recenti pandemie. Il Gruppo multidisciplinare di esperti di alto livello One Health (OHHLEP) ha recentemente pubblicato un documento nel quale si sottolinea la necessità di ridurre il rischio di insorgenza di malattie zoonotiche attraverso migliori misure di prevenzione, promuovendo così un approccio più efficiente di contrasto alla diffusione di tali malattie.
La diffusione delle Zoonosi è riconosciuta come causa predominante delle malattie infettive emergenti e come responsabile principale delle recenti pandemie. Il Gruppo multidisciplinare di esperti di alto livello One Health (OHHLEP) ha recentemente pubblicato un documento nel quale si sottolinea la necessità di ridurre il rischio di insorgenza di malattie zoonotiche attraverso migliori misure di prevenzione, promuovendo così un approccio più efficiente di contrasto alla diffusione di tali malattie. Quest’anno la stagione di trasmissione di malattie trasmesse da insetti ha avuto un inizio precoce in Italia. La circolazione del virus West Nile, infatti, è stata infatti confermata dalla presenza del virus in pool di zanzare e in avifauna nel paese già nel mese di maggio 2023. Sono state di conseguenza attivate precocemente le misure di prevenzione su trasfusioni e trapianti nelle aree interessate,
Quest’anno la stagione di trasmissione di malattie trasmesse da insetti ha avuto un inizio precoce in Italia. La circolazione del virus West Nile, infatti, è stata infatti confermata dalla presenza del virus in pool di zanzare e in avifauna nel paese già nel mese di maggio 2023. Sono state di conseguenza attivate precocemente le misure di prevenzione su trasfusioni e trapianti nelle aree interessate, Il numero di focolai di peste suina africana (PSA) nei maiali e di casi segnalati nei cinghiali selvatici nell’Unione europea (UE) è diminuito notevolmente nel 2022 rispetto all’anno precedente, si afferma in un nuovo rapporto pubblicato oggi dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La malattia è stata notificata in otto Paesi dell’UE nei maiali e in undici nei cinghiali selvatici.
Il numero di focolai di peste suina africana (PSA) nei maiali e di casi segnalati nei cinghiali selvatici nell’Unione europea (UE) è diminuito notevolmente nel 2022 rispetto all’anno precedente, si afferma in un nuovo rapporto pubblicato oggi dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La malattia è stata notificata in otto Paesi dell’UE nei maiali e in undici nei cinghiali selvatici. Vi siete mai chiesti quanto inquinamento da plastica si sia accumulato sulla superficie degli oceani di tutto il mondo? Un nuovo
Vi siete mai chiesti quanto inquinamento da plastica si sia accumulato sulla superficie degli oceani di tutto il mondo? Un nuovo  La catastrofe alluvionale che ha sconvolto l’Emilia-Romagna rappresenta l’ennesimo disastro ambientale che trova nei cambiamenti climatici e, più in particolare, nel riscaldamento globale la propria “vis a tergo”. Dal 2015 al 2022 si sono consecutivamente registrati su scala globale, infatti, gli 8 anni più caldi degli ultimi 140!
La catastrofe alluvionale che ha sconvolto l’Emilia-Romagna rappresenta l’ennesimo disastro ambientale che trova nei cambiamenti climatici e, più in particolare, nel riscaldamento globale la propria “vis a tergo”. Dal 2015 al 2022 si sono consecutivamente registrati su scala globale, infatti, gli 8 anni più caldi degli ultimi 140! La contaminazione di prodotti alimentari ha un impatto nefasto sulla loro qualità e pone seri rischi per la salute dei consumatori.
La contaminazione di prodotti alimentari ha un impatto nefasto sulla loro qualità e pone seri rischi per la salute dei consumatori. Presentato il 22 maggio, in occasione della Giornata mondiale della biodiversità, il National Biodiversity Future Center (NBFC), il primo centro di ricerca italiano dedicato alla biodiversità, che sarà coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).
Presentato il 22 maggio, in occasione della Giornata mondiale della biodiversità, il National Biodiversity Future Center (NBFC), il primo centro di ricerca italiano dedicato alla biodiversità, che sarà coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Il Centro di referenza europeo per il benessere dei volatili e delle piccole specie (EURCAW), del quale IZSLER fa parte, ha presentato in modo diffuso ed esaustivo un estratto delle modalità di valutazione del benessere dei tacchini in allevamento nella newsletter di aprile.
Il Centro di referenza europeo per il benessere dei volatili e delle piccole specie (EURCAW), del quale IZSLER fa parte, ha presentato in modo diffuso ed esaustivo un estratto delle modalità di valutazione del benessere dei tacchini in allevamento nella newsletter di aprile.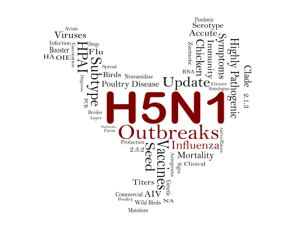 L’epidemia di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità
L’epidemia di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità  L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha revisionato la propria guida sulle modalità per valutare i rischi derivanti dai prodotti fitosanitari per api da miele, bombi e api solitarie. La
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha revisionato la propria guida sulle modalità per valutare i rischi derivanti dai prodotti fitosanitari per api da miele, bombi e api solitarie. La