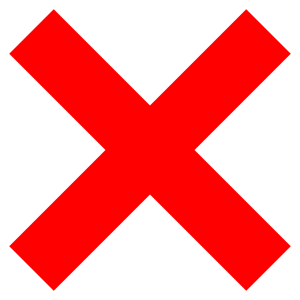 La “nuova” malattia insorta nella Repubblica Democratica del Congo, già messa a dura prova dall’epidemia di “Monkeypox”, avrebbe sin qui provocato almeno 450 casi e oltre 30 decessi, soprattutto fra i bambini al di sotto dei 5 anni.
La “nuova” malattia insorta nella Repubblica Democratica del Congo, già messa a dura prova dall’epidemia di “Monkeypox”, avrebbe sin qui provocato almeno 450 casi e oltre 30 decessi, soprattutto fra i bambini al di sotto dei 5 anni.
A dispetto della recentissima notizia relativa alla presenza di una “coinfezione” da Plasmodium falciparum/vivax/malariae – agenti della malaria, malattia endemica nel Continente Africano – nell’80% dei pazienti colpiti dalla “nuova” malattia congolese, fattispecie quest’ultima che renderebbe oltremodo di plausibile e giustificata la frequente coesistenza di quadri anemici negli stessi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le più importanti Istituzioni planetarie coinvolte nella lotta, nel controllo e nella profilassi delle malattie infettive (quali i prestigiosi “Centers for Disease Control and Prevention”/CDC di Atlanta, negli USA) brancolano ancora nel buio.
A tal proposito, infatti, andrebbe parimenti sottolineato che i succitati quadri anemici si rinvenirebbero comunemente associati ad altre manifestazioni cliniche comprendenti tosse, disturbi respiratori, cefalea ed ipertermia febbrile, elementi dai quali trarrebbe sostegno l’ipotesi di un coinvolgimento di uno o più patogeni respiratori, ai quali potrebbe essere altresì ascritto il ruolo di agente/agenti primario/primari.
Mutatis mutandis, ben prima che il virus responsabile dell’AIDS (Human Immunodeficiency Virus/HIV) venisse contemporaneamente e definitivamente identificato da Luc Montagnier (in Francia) e da Robert Gallo (in USA) nel lontano 1983, i sospetti iniziali si erano indirizzati, per oltre due anni, su Pneumocystis carinii (successivamente ribattezzato P. jirovecii), un protozoo di frequente riscontro nei pazienti affetti da AIDS e che “col senno di poi” avrebbe rappresentato la “punta dell’iceberg” dell’infezione da HIV, costituendo al tempo stesso uno degli svariati agenti opportunisti responsabili di infezioni secondarie in tali individui.
In effetti, si potrebbero citare molteplici esempi di infezioni secondarie sostenute da protozoi sia in persone che in animali primariamente infetti ad opera di agenti immunodeprimenti/immunodepressivi, virali e non, quali Toxoplasma gondii sempre in pazienti con AIDS nonché in cani affetti da cimurro (malattia causata da “Canine Distemper Virus”/CDV, un Morbillivirus) e in delfini con infezione da “Cetacean Morbillivirus” (CeMV, un altro Morbillivirus).
E, poiché di agenti protozoari anche nel caso di Plasmodium falciparum, P. vivax e P. malariae si tratta, l’ipotesi di un coinvolgimento secondario degli stessi nell’eziologia della misteriosa malattia congolese potrebbe risultare plausibile, tanto più in ragione del fatto che i disturbi respiratori osservati nei bambini affetti da siffatta “sindrome X” non rientrerebbero fra i reperti clinico-sintomatologici tipici della malaria.
Se poi andiamo a scavare, neppure più di tanto, nell’affascinante storia delle malattie infettive, fatto salvo il succitato eloquente esempio dell’AIDS, ci accorgiamo che l’identificazione di SARS-CoV, il betacoronavirus responsabile della SARS – malattia riconosciuta per la prima volta nel 2002 dal medico italiano Carlo Urbani, poi deceduto a causa della stessa – è stata preceduta dall’attribuzione, ad opera di ricercatori cinesi, di una responsabilità causale non gia’ ad un agente virale, ma bensi’ a batteri del genere Chlamydia.
Nel mondo animale poi, tanto per citare un ulteriore, eloquente esempio, prima che si addivenisse alla scoperta di una serie di nuovi membri del genere Morbillivirus quali responsabili di devastanti epidemie fra i mammiferi marini (Pinnipedi e Cetacei), la cui salute e conservazione appaiono sempre più minacciate per mano dell’uomo, altri agenti erano stati indiziati quali noxae causali, primo fra tutti Herpesvirus, rivelatosi in seguito un patogeno frequentemente coinvolto in infezioni secondarie. Illuminanti esempi di questo tipo non mancano neppure tra gli ospiti animali invertebrati, come chiaramente ci mostrano i ripetuti episodi di mortalità collettiva che in anni recenti hanno interessato le popolazioni di nacchere (Pinna nobilis) in più aree del Mediterraneo. Si tratta del più grande mollusco bivalve lamellibranco presente nella regione, i cui eventi di mortalità collettiva erano stati ricondotti all’azione di un protozoo (Haplosporidium pinnae) e di batteri (Mycobacterium sherrisii, Vibrio mediterranei) prima che si addivenisse a definirne l’eziologia primaria, ascrivibile ad un piccolo virus a RNA facente parte dell’ordine Picornavirales, rispetto al quale il parassita e i due batteri anzidetti andrebbero considerati come agenti opportunisti d’irruzione secondaria.
Alla luce di quanto sopra, verrebbe da dire che la “malattia X” recentemente identificata in Congo non rappresenti un’eccezione alla regola secondo cui l’identificazione certa di qualsivoglia agente causale di qualsivoglia nuova malattia infettiva (e non) sia anticipata, giocoforza, da “errori” grazie ai quali l’accertamento della responsabilità eziologica primaria emergera’ a tempo debito e a coronamento degli sforzi profusi dalla Comunità Scientifica, in una sana ottica di collaborazione intersettoriale e multidisciplinare e, nondimeno, nel segno della “One Health”, la salute unica di uomo, animali ed ambiente.
Historia Magistra Vitae!
Giovanni Di Guardo,
DVM, Dipl. ECVP,
Già Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo

 Inquinamento, dighe, agricoltura intensiva, specie invasive. E così rischiamo di perdere la bellezza di 23mila specie che vivono negli ecosistemi d’acqua dolce, quasi un quarto del totale. Sarebbe un duro colpo alla biodiversità: a lanciare l’allarme è un gruppo di scienziati della International Union for Conservation of Nature (Iucn), un’organizzazione non governativa internazionale con sede in Svizzera, in uno studio appena pubblicato sulle pagine della rivista Nature. Gli autori auspicano che i risultati del loro lavoro spronino e aiutino i decisori a intraprendere al più presto tutte le azioni necessarie a preservare la biodiversità delle acque dolci e scongiurare il pericolo di estinzione delle specie a rischio.
Inquinamento, dighe, agricoltura intensiva, specie invasive. E così rischiamo di perdere la bellezza di 23mila specie che vivono negli ecosistemi d’acqua dolce, quasi un quarto del totale. Sarebbe un duro colpo alla biodiversità: a lanciare l’allarme è un gruppo di scienziati della International Union for Conservation of Nature (Iucn), un’organizzazione non governativa internazionale con sede in Svizzera, in uno studio appena pubblicato sulle pagine della rivista Nature. Gli autori auspicano che i risultati del loro lavoro spronino e aiutino i decisori a intraprendere al più presto tutte le azioni necessarie a preservare la biodiversità delle acque dolci e scongiurare il pericolo di estinzione delle specie a rischio. Che cos’è l’influenza aviaria? Perché se ne parla?
Che cos’è l’influenza aviaria? Perché se ne parla?
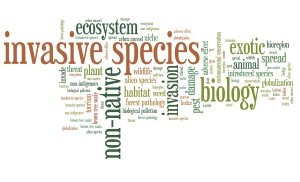 Una formula per prevedere se una specie invasiva riuscirà a stabilirsi in un nuovo ecosistema. È il frutto di uno
Una formula per prevedere se una specie invasiva riuscirà a stabilirsi in un nuovo ecosistema. È il frutto di uno  Le numerose segnalazioni da parte dei cittadini, relative a presunti o effettivi avvistamenti del ragno violino, hanno spinto l’
Le numerose segnalazioni da parte dei cittadini, relative a presunti o effettivi avvistamenti del ragno violino, hanno spinto l’ I sistemi di sorveglianza sono necessari per controllare la diffusione delle malattie emergenti, tra cui le nuove zoonosi, per poter intervenire precocemente. “La situazione attuale, però, nonostante tutti gli sforzi non è ancora sufficiente e la dimostrazione è rappresentata dagli eventi che, negli ultimi anni, hanno colpito duramente anche in Italia”, spiega Gaddo Francesco Vicenzoni, già direttore della struttura complessa territoriale di Verona e Vicenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe).
I sistemi di sorveglianza sono necessari per controllare la diffusione delle malattie emergenti, tra cui le nuove zoonosi, per poter intervenire precocemente. “La situazione attuale, però, nonostante tutti gli sforzi non è ancora sufficiente e la dimostrazione è rappresentata dagli eventi che, negli ultimi anni, hanno colpito duramente anche in Italia”, spiega Gaddo Francesco Vicenzoni, già direttore della struttura complessa territoriale di Verona e Vicenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). C’entrano anche le zanzare se in Africa le epidemie del virus Zika sono rare. Un equilibrio che tuttavia potrebbe essee alterato dai cambiamenti climatici. Uno studio dell’High Meadows Environmental Institute (HMEI) presso la Princeton University, l’Institut Pasteur e della University of California, San Diego (US), pubblicato su The Lancet Planetary Health, dimostrerebbe che i bassi tassi correlati alla diffusione del virus Zika, responsabile di difetti alla nascita e di devastanti epidemie nelle Americhe dal 2015 al 2016, possa dipendere dalla composizione genetica delle zanzare autoctone africane. “Esistono due specie di zanzara che diffondono Zika”, dichiara Jamie Caldwell, Associate Research Scholar presso l’HMEI, “ciascuna con tipiche preferenze alimentari e capacità di trasmissione della malattia. Questa differenza genetica potrebbe spiegare perché Zika ha ampiamente risparmiato l’Africa, continente in cui il virus è stato originariamente scoperto, nonostante la presenza di grandi popolazioni di zanzare e le condizioni climatiche favorevoli alla loro attività”. In particolare la forma specializzata umana preferisce pungere gli esseri umani ed ha tendenza a vivere in aree urbane densamente popolate.
C’entrano anche le zanzare se in Africa le epidemie del virus Zika sono rare. Un equilibrio che tuttavia potrebbe essee alterato dai cambiamenti climatici. Uno studio dell’High Meadows Environmental Institute (HMEI) presso la Princeton University, l’Institut Pasteur e della University of California, San Diego (US), pubblicato su The Lancet Planetary Health, dimostrerebbe che i bassi tassi correlati alla diffusione del virus Zika, responsabile di difetti alla nascita e di devastanti epidemie nelle Americhe dal 2015 al 2016, possa dipendere dalla composizione genetica delle zanzare autoctone africane. “Esistono due specie di zanzara che diffondono Zika”, dichiara Jamie Caldwell, Associate Research Scholar presso l’HMEI, “ciascuna con tipiche preferenze alimentari e capacità di trasmissione della malattia. Questa differenza genetica potrebbe spiegare perché Zika ha ampiamente risparmiato l’Africa, continente in cui il virus è stato originariamente scoperto, nonostante la presenza di grandi popolazioni di zanzare e le condizioni climatiche favorevoli alla loro attività”. In particolare la forma specializzata umana preferisce pungere gli esseri umani ed ha tendenza a vivere in aree urbane densamente popolate.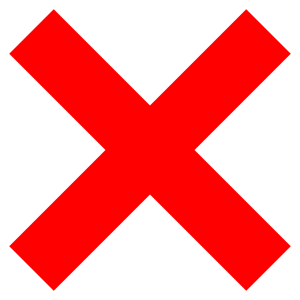 La “nuova” malattia insorta nella Repubblica Democratica del Congo, già messa a dura prova dall’epidemia di “Monkeypox”, avrebbe sin qui provocato almeno 450 casi e oltre 30 decessi, soprattutto fra i bambini al di sotto dei 5 anni.
La “nuova” malattia insorta nella Repubblica Democratica del Congo, già messa a dura prova dall’epidemia di “Monkeypox”, avrebbe sin qui provocato almeno 450 casi e oltre 30 decessi, soprattutto fra i bambini al di sotto dei 5 anni.