Botulismo aviario e avifauna selvatica: prima segnalazione in Italia di una grave epidemia in un’area protetta
 Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2019 e per i successivi tre anni, l’epidemia ha interessato un’area all’interno del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna. Uno studio, pubblicato sulla rivista Animals e redatto con il contribuito ricercatrici e ricercatori ISPRA, analizza la successione degli eventi in relazione alle condizioni ambientali e alle misure gestionali di contenimento
Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2019 e per i successivi tre anni, l’epidemia ha interessato un’area all’interno del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna. Uno studio, pubblicato sulla rivista Animals e redatto con il contribuito ricercatrici e ricercatori ISPRA, analizza la successione degli eventi in relazione alle condizioni ambientali e alle misure gestionali di contenimento
Il botulismo è una malattia neurologica che colpisce gli umani e altre specie animali ed è collegata alle neurotossine di diverso tipo prodotte da batteri del genere Clostridium, solitamente riconducibili a C. botulinum. Tra queste neurotossine alcune sono responsabili del botulismo umano, ad esempio quello legato alle conserve alimentari, altre colpiscono gli uccelli selvatici. In tali volatili, il botulismo aviario è causa di episodi di mortalità registrati in Italia e nel mondo a volte con gravi impatti sulle popolazioni di uccelli come accaduto durante la moria del 1932 nel Grande Lago Salato nell’America settentrionale che portò alla morte di circa 250.000 animali.
Il 5 settembre del 2019 nell’area della Valle Mandriole, nel Parco regionale Delta del Po Emilia-Romagna in provincia di Ravenna, furono rilevate alcune carcasse di uccelli che analizzate presso i laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER mostrarono la presenza di clostridi produttori di neurotossine.
Tra le prime misure prese dal tavolo tecnico istituito per gestire l’emergenza botulismo aviario — tavolo coordinato dal Comune di Ravenna, con la partecipazione di tecnici e rappresentanti di numerosi enti territoriali e stakeholder locali, tra i quali anche l’Ente Parco del Delta del Po, il servizio veterinario della AUSL della Romagna, la Regione Emilia e Romagna – vi furono il recupero dei soggetti intossicati ancora vivi e la pronta rimozione delle carcasse degli uccelli deceduti. Questa azione risulta molto importante perché nelle carcasse si sviluppano le larve delle mosche carnarie che sono degli accumulatori biologici della neurotossina presente negli animali morti e quando vengono a loro volta predate da altri uccelli li intossicano dando vita ad un ciclo che sostiene e amplifica gli effetti e le possibilità di ulteriore trasmissione della malattia.
Altro intervento deciso per bloccare il ciclo vitale dei ceppi tossigeni di Clostridium spp. fu quello di agire sui livelli d’acqua della valle. Nelle zone umide, soprattutto d’acqua dolce, tali batteri si sviluppano quando materiale organico di origine vegetale o animale si decompone in concomitanza con temperature alte e carenza di ossigeno nell’acqua (anossia), esattamente le condizioni che, insieme alla scarsità di precipitazioni, si manifestarono nell’estate 2019. Le alternative praticabili per affrontare questa situazione di emergenza erano due: l’inondazione o il disseccamento della Valle Mandriole. Entrambe le azioni possono contribuire a ridurre la presenza del batterio e il suo impatto negativo, rispettivamente riducendone la moltiplicazione ed allontanando gli uccelli acquatici prime vittime della malattia. Si decise di procedere con il disseccamento per evitare che uccelli acquatici continuassero a posarsi nelle poche pozze rimaste. La strategia risultò efficace e la maggior parte dei 2158 uccelli vittima della malattia morirono nei primi giorni dall’insorgenza della stessa e prima delle contromisure mese in atto.
I casi di botulismo aviario verificatisi durante l’evento primario tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2019 e nei successivi tre anni sono stati documentati e recentemente pubblicati sulla rivista Animals. Nell’articolo, redatto da ricercatori ISPRA con la collaborazione di veterinari e biologi del Comune di Ravenna, della AUSL della Romagna e dell’IZSLER, la successione degli eventi è analizzata in relazione alle condizioni ambientali e alle misure gestionali di contenimento, monitoraggio e prevenzione derivate da questa esperienza e a quanto accaduto nei tre anni successivi al ripresentarsi di condizioni favorevoli per il botulismo aviario.
La sopravvivenza delle spore di Clostridium spp. in uno stato di quiescenza nel terreno e nel substrato delle zone umide, ed anche la persistenza invernale delle tossine delle pupe svernanti di mosca carnaria sottolineano la necessità di monitorare le aree colpite dal botulismo, poiché al verificarsi di condizioni adatte la malattia può ripresentarsi anche dopo anni dal primo evento.
Valle Mandriole, sito di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar compresa tra le aree protette regionali e ZSC/ZPS della Rete Natura 2000, risulta essere come le altre zone umide tra gli ecosistemi più fragili e più esposti ai cambiamenti climatici di origine antropogenica. Lo sviluppo delle spore di Clostridium spp., favorito da condizioni di anossia e decomposizione di biomassa organica in presenza delle alte temperature estive, può diventare un fattore di mortalità importante per gli uccelli acquatici che possono ingerire e quindi diffondere neurotossina botulinica.
Lo studio e la gestione di questa emergenza ambientale ha messo in relazione il ciclo vitale del Clostridium botulinum, la gestione idrica dei bacini legata all’anossia delle acque, i cambiamenti climatici, lo stato di salute dell’avifauna stanziale e migratrice, rendendo esplicita la complessità dei sistemi naturali e la necessità di adeguate azioni di prevenzione e gestione di eventi emergenziali.
Leggi l’articolo in Open Access
 Uno studio realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo (IZSAM) dimostra la validità del succo di carne di maiale come matriale diagnostico per individuare il virus responsabile della Peste Suina Africana (PSA).
Uno studio realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo (IZSAM) dimostra la validità del succo di carne di maiale come matriale diagnostico per individuare il virus responsabile della Peste Suina Africana (PSA). Quattordici morti e 254 feriti: è il bilancio di 199 incidenti gravi con animali avvenuti lo scorso anno sulle strade italiane, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale.
Quattordici morti e 254 feriti: è il bilancio di 199 incidenti gravi con animali avvenuti lo scorso anno sulle strade italiane, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale. Secondo un interessante articolo recentemente pubblicato sulla prestigiosa Rivista Science Advances, la lunga aspettativa di vita, financo a 150 anni, caratterizzante varie specie di Cetacei Misticeti (cioè provvisti di fanoni, alias balene, balenottere, etc.) quali la balena franca australe (Eubalaena australis) costituirebbe un modello potenzialmente utile ai fini dello studio della longevità tipica di altre specie, fra le quali anche la nostra (1).
Secondo un interessante articolo recentemente pubblicato sulla prestigiosa Rivista Science Advances, la lunga aspettativa di vita, financo a 150 anni, caratterizzante varie specie di Cetacei Misticeti (cioè provvisti di fanoni, alias balene, balenottere, etc.) quali la balena franca australe (Eubalaena australis) costituirebbe un modello potenzialmente utile ai fini dello studio della longevità tipica di altre specie, fra le quali anche la nostra (1). In Europa vivono sei specie di grandi carnivori: orso, lupo, lince eurasiatica, lince iberica, ghiottone e sciacallo dorato. La maggior parte delle popolazioni di questi predatori ha mostrato negli ultimi sei anni un complessivo trend di crescita sia numerica che di distribuzione, come dimostra
In Europa vivono sei specie di grandi carnivori: orso, lupo, lince eurasiatica, lince iberica, ghiottone e sciacallo dorato. La maggior parte delle popolazioni di questi predatori ha mostrato negli ultimi sei anni un complessivo trend di crescita sia numerica che di distribuzione, come dimostra  Il commercio di animali esotici venduti come pet, animali d’affezione, sembra essere in perenne crescita e, alimentato anche dai social media, vede anche di continuo nuove specie che si aggiungono alla lista di quelle in voga, dai
Il commercio di animali esotici venduti come pet, animali d’affezione, sembra essere in perenne crescita e, alimentato anche dai social media, vede anche di continuo nuove specie che si aggiungono alla lista di quelle in voga, dai  E’ di poche settimane fa la notizia relativa ad un ulteriore ampliamento del già ampio spettro d’ospite posseduto dal betacoronavirus SARS-CoV-2, il famigerato agente responsabile della pandemia da CoViD-19.
E’ di poche settimane fa la notizia relativa ad un ulteriore ampliamento del già ampio spettro d’ospite posseduto dal betacoronavirus SARS-CoV-2, il famigerato agente responsabile della pandemia da CoViD-19.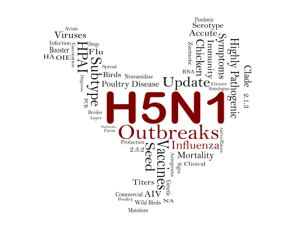 I Virus dell’Influenza Aviaria (VIA) sono oggetto di preoccupazione a causa del loro potenziale impatto sulla salute dei volatili domestici, della fauna selvatica e, se zoonosici, dell’uomo.
I Virus dell’Influenza Aviaria (VIA) sono oggetto di preoccupazione a causa del loro potenziale impatto sulla salute dei volatili domestici, della fauna selvatica e, se zoonosici, dell’uomo.