Resistenza agli antibiotici: un nemico silenzioso alimentato dal cambiamento climatico
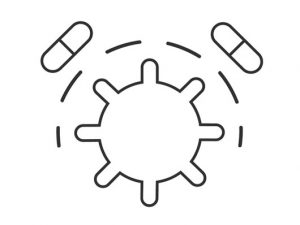 Si è appena chiusa la Cop29 a Baku in Azerbaigian. Trovare un accordo sui nuovi impegni condivisi a livello internazionale per contrastare il cambiamento climatico è stato molto difficile e le contestazioni non mancano.
Si è appena chiusa la Cop29 a Baku in Azerbaigian. Trovare un accordo sui nuovi impegni condivisi a livello internazionale per contrastare il cambiamento climatico è stato molto difficile e le contestazioni non mancano.
L’accordo raggiunto, in estrema sintesi, stanzia circa 1.300 miliardi di dollari (circa 1.250 miliardi di euro) di aiuti, ma di questi soltanto 300 miliardi arriveranno come contributi e prestiti a basso interesse da parte dei Paesi sviluppati. I soldi sono destinati ai Paesi in via di sviluppo, meno responsabili delle emissioni di gas serra ma più colpiti dagli effetti del riscaldamento globale, per liberarsi dal carbone, dal petrolio e dal gas che causano il surriscaldamento del pianeta e per affrontare i danni causati dalle condizioni climatiche estreme.
Tutti gli altri soldi dovranno essere raccolti non si sa bene come, forse da finanziatori privati, aziende, tasse o altro, cifre che nei fatti devono essere ancora stanziate e definite.
Ogni riferimento esplicito della “transizione” verso l’uscita dai combustibili fossili, il principale risultato della Cop28 di Dubai, è scomparso, nonostante i tentativi dell’Unione europea, osteggiata dall’Arabia Saudita. Rimane una priorità per il futuro, ma senza monitoraggio concreto.
Eppure, il cambiamento climatico non aspetta. E non è solo una questione di temperature che salgono e ghiacciai che si sciolgono. C’è un altro nemico silenzioso che sta crescendo all’ombra del riscaldamento globale: la resistenza agli antibiotici.
La risposta alla domanda se il cambiamento climatico stia peggiorando l’antibiotico resistenza è un chiaro “sì”, come confermato da Nature. L’equazione è semplice: il riscaldamento globale favorisce la crescita dei batteri, l’aumento delle infezioni richiede più antibiotici e l’uso massiccio di questi ultimi alimenta la resistenza.
Gli eventi meteorologici estremi, come uragani, siccità e inondazioni, sono un’altra faccia del problema. Questi disastri spesso compromettono l’accesso all’acqua pulita e aumentano il rischio di infezioni. In Florida, dopo l’uragano Ian del 2022, è stata rilevata una concentrazione anomala di batteri resistenti nelle acque costiere, a dimostrazione di come il cambiamento climatico possa incentivare la proliferazione dei super-batteri.
Fonte: trendsanita.it
 Fece giustamente molta impressione lo studio pubblicato nel 2009 dall’Istituto Mario Negri di Milano sull’importanza di sorvegliare le acque fognarie per stimare il consumo di droghe nella popolazione (1). Lo studio descriveva un nuovo metodo per stimare il consumo di droghe nella popolazione basato sulla misura dei residui delle droghe eliminati con le urine dai consumatori e veicolati tramite le acque fognarie ai depuratori cittadini. Il metodo è stato utilizzato per stimare i quantitativi di cannabis, cocaina, eroina e amfetamine consumati giornalmente nelle città di Milano, Lugano e Londra.
Fece giustamente molta impressione lo studio pubblicato nel 2009 dall’Istituto Mario Negri di Milano sull’importanza di sorvegliare le acque fognarie per stimare il consumo di droghe nella popolazione (1). Lo studio descriveva un nuovo metodo per stimare il consumo di droghe nella popolazione basato sulla misura dei residui delle droghe eliminati con le urine dai consumatori e veicolati tramite le acque fognarie ai depuratori cittadini. Il metodo è stato utilizzato per stimare i quantitativi di cannabis, cocaina, eroina e amfetamine consumati giornalmente nelle città di Milano, Lugano e Londra. Abbiamo tutti acquisito familiarità con le mutazioni del virus responsabile del Sars-CoV-2 nel corso della pandemia e probabilmente tutti possiamo elencarne le varianti: Alpha, Delta e Omicron. La preoccupazione che ha destato la comparsa di nuove forme di Covid-19 offre una misura della pericolosità di questo fenomeno che è del tutto naturale.
Abbiamo tutti acquisito familiarità con le mutazioni del virus responsabile del Sars-CoV-2 nel corso della pandemia e probabilmente tutti possiamo elencarne le varianti: Alpha, Delta e Omicron. La preoccupazione che ha destato la comparsa di nuove forme di Covid-19 offre una misura della pericolosità di questo fenomeno che è del tutto naturale. L’interazione tra robot e animali può offrire soluzioni innovative alla crisi climatica e ambientale. È questa la tesi proposta da due scienziati europei, Thomas Schmickl, professore presso l’University of Graz, e Donato Romano, ricercatore presso l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in un articolo pubblicato sulla rivista
L’interazione tra robot e animali può offrire soluzioni innovative alla crisi climatica e ambientale. È questa la tesi proposta da due scienziati europei, Thomas Schmickl, professore presso l’University of Graz, e Donato Romano, ricercatore presso l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in un articolo pubblicato sulla rivista  Un nuovo calabrone è stato trovato in Spagna, nella regione delle Asturie affacciata sul Mar Cantabrico, nel Nord della penisola Iberica.
Un nuovo calabrone è stato trovato in Spagna, nella regione delle Asturie affacciata sul Mar Cantabrico, nel Nord della penisola Iberica. Potrebbe arrivare ancora dall’Asia la nuova minaccia per le api, la cui salute è già messa a dura prova dalla globalizzazione, dall’effetto dei cambiamenti climatici e dell’abuso di fitofarmaci. Si tratta dell’acaro Tropilaelaps mercedesae, un ectoparassita (che vive cioè sulla superficie esterna dell’ospite) originario delle api mellifere asiatiche giganti (Apis dorsata, A. breviligula e A. laboriosa), ma che sta provocando effetti negativi anche sulle colonie di api mellifere occidentali (Apis mellifera). Dopo il ritrovamento in Russia, l’acaro è adesso segnalato per la prima volta in Georgia, confermando la sua espansione geografica.
Potrebbe arrivare ancora dall’Asia la nuova minaccia per le api, la cui salute è già messa a dura prova dalla globalizzazione, dall’effetto dei cambiamenti climatici e dell’abuso di fitofarmaci. Si tratta dell’acaro Tropilaelaps mercedesae, un ectoparassita (che vive cioè sulla superficie esterna dell’ospite) originario delle api mellifere asiatiche giganti (Apis dorsata, A. breviligula e A. laboriosa), ma che sta provocando effetti negativi anche sulle colonie di api mellifere occidentali (Apis mellifera). Dopo il ritrovamento in Russia, l’acaro è adesso segnalato per la prima volta in Georgia, confermando la sua espansione geografica. Nonostante la speranza iniziale ispirata dall’accordo di Parigi del 2015, il mondo è ora pericolosamente vicino a violare il suo obiettivo di limitare il riscaldamento medio pluriennale globale a 1,5 °C. La temperatura media annuale della superficie ha raggiunto un massimo record di 1,45 °C al di sopra della linea di base preindustriale nel 2023 e nuovi picchi di temperatura sono stati registrati per tutto il 2024. Gli estremi climatici risultanti stanno mietendo sempre più vittime e mezzi di sostentamento in tutto il mondo.
Nonostante la speranza iniziale ispirata dall’accordo di Parigi del 2015, il mondo è ora pericolosamente vicino a violare il suo obiettivo di limitare il riscaldamento medio pluriennale globale a 1,5 °C. La temperatura media annuale della superficie ha raggiunto un massimo record di 1,45 °C al di sopra della linea di base preindustriale nel 2023 e nuovi picchi di temperatura sono stati registrati per tutto il 2024. Gli estremi climatici risultanti stanno mietendo sempre più vittime e mezzi di sostentamento in tutto il mondo. Le piogge copiose, le alluvioni e il caldo torrido e prolungato sono gli effetti del riscaldamento terrestre con cui gran parte dell’umanità sta facendo i conti. Fra le conseguenze, c’è anche la crescita dei casi di zoonosi. Se in passato, infatti, si poteva ritenere la sola stagione estiva il periodo a cui fare maggiore attenzione per la diffusione di zecche, zanzare, pulci o flebotomi, oggi non è più così. Le temperature miti, anche nei mesi autunnali e invernali, hanno allungato il ciclo di vita dei possibili vettori che proliferano in diversi ambienti e agevolato l’introduzione di specie considerate prima aliene. Di fronte a questo nuovo scenario, devono cambiare le strategie di prevenzione e intervento. Al nesso tra i mutamenti climatici e le zoonosi è dedicato il secondo appuntamento della rubrica “Salute e Zoonosi: prevenire e proteggersi”, curata dalla redazione di Aboutpharma, in collaborazione con Boehringer Ingelheim.
Le piogge copiose, le alluvioni e il caldo torrido e prolungato sono gli effetti del riscaldamento terrestre con cui gran parte dell’umanità sta facendo i conti. Fra le conseguenze, c’è anche la crescita dei casi di zoonosi. Se in passato, infatti, si poteva ritenere la sola stagione estiva il periodo a cui fare maggiore attenzione per la diffusione di zecche, zanzare, pulci o flebotomi, oggi non è più così. Le temperature miti, anche nei mesi autunnali e invernali, hanno allungato il ciclo di vita dei possibili vettori che proliferano in diversi ambienti e agevolato l’introduzione di specie considerate prima aliene. Di fronte a questo nuovo scenario, devono cambiare le strategie di prevenzione e intervento. Al nesso tra i mutamenti climatici e le zoonosi è dedicato il secondo appuntamento della rubrica “Salute e Zoonosi: prevenire e proteggersi”, curata dalla redazione di Aboutpharma, in collaborazione con Boehringer Ingelheim. Vespa velutina torna a farsi viva in Lombardia dopo più di due anni dall’ultima segnalazione.
Vespa velutina torna a farsi viva in Lombardia dopo più di due anni dall’ultima segnalazione. Che cos’è la fenologia?
Che cos’è la fenologia?