Fenologia, questa sconosciuta
 Che cos’è la fenologia?
Che cos’è la fenologia?
“Per fenologia intendiamo tutti quegli eventi che sono ricorrenti durante l’anno nella vita di un animale o di una pianta: ad esempio il periodo di deposizione delle uova, il periodo riproduttivo, delle nascite, di ingresso e di uscita dall’ibernazione, il periodo di arrivo dalle migrazioni…” spiega Sandro Bertolino, docente di Ecologia e Conservazione della natura all’Università degli Studi di Torino. “Insomma, sono tutti aspetti della fenologia quelli che caratterizzano il ciclo vitale di un individuo e che si ripetono di anno in anno. Questo per quanto riguarda gli animali. Esempi per le piante possono essere invece il periodo di comparsa delle foglie, il periodo della fioritura e di comparsa di semi e frutti e via dicendo”.
Ma perché è un concetto così strettamente correlato al cambiamento climatico? “Quello che si è visto col cambiamento climatico è che l’aumento della temperatura ha degli effetti sulla stragrande maggioranza degli organismi, che cambiano il periodo della loro fenologia. Questo nelle piante determina, in genere, un anticipo della riproduzione o della comparsa delle foglie e per gli insetti un anticipo della deposizione delle uova, ad esempio per molti lepidotteri o altre specie la comparsa dei bruchi è anticipata rispetto al passato”.
Lo stato dell’arte degli studi
“Ci sono studi su molte specie, di vertebrati e invertebrati” prosegue Bertolino. “In molti uccelli, ad esempio, la nascita dei piccoli è sincronizzata nel periodo di massima di disponibilità alimentare. Nelle cince e in altre specie, i piccoli vengono alimentati coi bruchi, quindi è conveniente avere i piccoli quando c’è il massimo di disponibilità di bruchi. Il problema è che con l’anticipo dello sviluppo della vegetazione a causa dell’aumento delle temperature e l’anticipo della deposizione delle uova da parte dei lepidotteri, si verifica spesso uno sfasamento temporale – detto mismatch – di diversi giorni o addirittura settimane tra il picco massimo di disponibilità dei bruchi e il periodo di massima richiesta di cibo da parte dei piccoli degli uccelli. Bisogna infatti considerare che gli insetti riescono a reagire più velocemente rispetto ai vertebrati ai cambiamenti climatici. Per gli uccelli è più difficile anticipare il periodo di deposizione delle uova, essendo questo regolato da un ciclo fisiologico più complesso. Se gli insetti possono anticipare il picco massimo di abbondanza anche di una o due settimane, gli uccelli spesso non riescono ad anticipare la deposizione delle uova e la loro schiusa. Questo sfasamento temporale può determinare una minore disponibilità alimentare nel momento delle massime esigenze da parte dei nascituri, con potenziali conseguenze negative nel lungo termine”.
Fonte: piemonteparchi.it
 Il commercio di animali esotici venduti come pet, animali d’affezione, sembra essere in perenne crescita e, alimentato anche dai social media, vede anche di continuo nuove specie che si aggiungono alla lista di quelle in voga, dai
Il commercio di animali esotici venduti come pet, animali d’affezione, sembra essere in perenne crescita e, alimentato anche dai social media, vede anche di continuo nuove specie che si aggiungono alla lista di quelle in voga, dai  “Una parola ricorrente durante i nostri lavori è stata “trust”, fiducia, perché i Paesi del G7 hanno chiaro il loro ruolo di leader nel proporre a livello globale le migliori pratiche per garantire la salute ed il benessere animale e la sicurezza alimentare, affinché il commercio di prodotti agroalimentari sia basato su regole sanitarie chiare e condivise e, appunto, sulla fiducia reciproca fra i Paesi”. Queste le parole di Ugo Della Marta, Capo dei Servizi Veterinari italiani, che ha presieduto il G7 della veterinaria, evento che ha riunito a Padova le delegazioni veterinarie dei Paesi più industrializzati per fare il punto sullo stato della salute animale sul nostro pianeta.
“Una parola ricorrente durante i nostri lavori è stata “trust”, fiducia, perché i Paesi del G7 hanno chiaro il loro ruolo di leader nel proporre a livello globale le migliori pratiche per garantire la salute ed il benessere animale e la sicurezza alimentare, affinché il commercio di prodotti agroalimentari sia basato su regole sanitarie chiare e condivise e, appunto, sulla fiducia reciproca fra i Paesi”. Queste le parole di Ugo Della Marta, Capo dei Servizi Veterinari italiani, che ha presieduto il G7 della veterinaria, evento che ha riunito a Padova le delegazioni veterinarie dei Paesi più industrializzati per fare il punto sullo stato della salute animale sul nostro pianeta. In occasione del Planetary Health Festival, Il Festival Italiano della Salute Planetaria, svoltosi a Verona dal 3 al 5 ottobre, si è tenuto un panel dedicato a un tema di crescente rilevanza globale: l’impatto invisibile delle micro e nanoplastiche (MNP) sulla salute umana. Durante l’incontro, è stato presentato lo studio intitolato Tutta la plastica che non vediamo. Rapporto sulla presenza delle micro e nanoplastiche nel corpo umano, commissionato da VERA Studio a un gruppo di esperti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
In occasione del Planetary Health Festival, Il Festival Italiano della Salute Planetaria, svoltosi a Verona dal 3 al 5 ottobre, si è tenuto un panel dedicato a un tema di crescente rilevanza globale: l’impatto invisibile delle micro e nanoplastiche (MNP) sulla salute umana. Durante l’incontro, è stato presentato lo studio intitolato Tutta la plastica che non vediamo. Rapporto sulla presenza delle micro e nanoplastiche nel corpo umano, commissionato da VERA Studio a un gruppo di esperti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. I casi di dengue sono aumentati in tutte e sei le regioni dell’Oms. Una chiamata all’zione per combattere anche le altre malattie arbovirosi trasmesse da Aedes
I casi di dengue sono aumentati in tutte e sei le regioni dell’Oms. Una chiamata all’zione per combattere anche le altre malattie arbovirosi trasmesse da Aedes L’espansione di Vespa velutina segna due record con i ritrovamenti dell’insetto a centinaia di chilometri di distanza dalla zona in cui ormai è pressoché stabile, cioè la Liguria e la Toscana.
L’espansione di Vespa velutina segna due record con i ritrovamenti dell’insetto a centinaia di chilometri di distanza dalla zona in cui ormai è pressoché stabile, cioè la Liguria e la Toscana.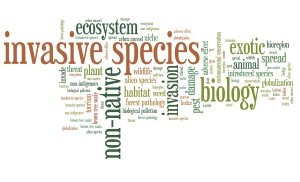 Per l’Europa alcuni sono innocui come il coleottero dei chicchi di caffè, un parassita che attacca piante che in Europa crescono solo in un paio di campi sperimentali in Sicilia. Altri insetti della stessa famiglia sono, al contrario, molto più pericolosi. Ad esempio quelli del genere Euwallacea, appartenenti al gruppo dei coleotteri dell’ambrosia, colonizzano il legno sotto la corteccia degli alberi e per sopravvivere coltivano funghi che poi conducono la pianta al capolinea.
Per l’Europa alcuni sono innocui come il coleottero dei chicchi di caffè, un parassita che attacca piante che in Europa crescono solo in un paio di campi sperimentali in Sicilia. Altri insetti della stessa famiglia sono, al contrario, molto più pericolosi. Ad esempio quelli del genere Euwallacea, appartenenti al gruppo dei coleotteri dell’ambrosia, colonizzano il legno sotto la corteccia degli alberi e per sopravvivere coltivano funghi che poi conducono la pianta al capolinea. La Commissione Ue ha adottato
La Commissione Ue ha adottato  Non è sicuramente facile parlare di temi come la perdita di biodiversità, la comparsa di nuovi virus, l’evoluzione o il rapporto con animali pericolosi tenendo i lettori incollati al libro con tomi di quattrocento e più pagine, ma
Non è sicuramente facile parlare di temi come la perdita di biodiversità, la comparsa di nuovi virus, l’evoluzione o il rapporto con animali pericolosi tenendo i lettori incollati al libro con tomi di quattrocento e più pagine, ma  A rendere un siffatto scenario ancora più allarmante contribuisce il comprovato ruolo di potenti “attrattori e concentratori” esplicato dalle MNP nei confronti di una vasta gamma di “contaminanti ambientali persistenti”, ivi compresi metalli pesanti quali il metil-mercurio (MeHg), oltre a numerose categorie di xenobiotici di natura organica quali le diossine, i policlorobifenili (PCB), gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e le sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS) (Xiang et al., 2022).
A rendere un siffatto scenario ancora più allarmante contribuisce il comprovato ruolo di potenti “attrattori e concentratori” esplicato dalle MNP nei confronti di una vasta gamma di “contaminanti ambientali persistenti”, ivi compresi metalli pesanti quali il metil-mercurio (MeHg), oltre a numerose categorie di xenobiotici di natura organica quali le diossine, i policlorobifenili (PCB), gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e le sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS) (Xiang et al., 2022).