Le nitrosammine negli alimenti destano preoccupazioni per la salute
 Sono queste le risultanze della valutazione EFSA sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di nitrosammine negli alimenti: dieci nitrosammine presenti negli alimenti sono cancerogene (possono provocare il cancro) e genotossiche (possono danneggiare il DNA).
Sono queste le risultanze della valutazione EFSA sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di nitrosammine negli alimenti: dieci nitrosammine presenti negli alimenti sono cancerogene (possono provocare il cancro) e genotossiche (possono danneggiare il DNA).
L’EFSA ha consultato i portatori di interesse esterni sul suo progetto di parere e le numerose osservazioni ricevute sono state prese in debita considerazione in fase di redazione conclusiva.
Potenziali rischi per la salute
L’EFSA ha condotto la propria valutazione stimando il danno potenziale causato dalle nitrosammine all’uomo e agli animali e valutando l’esposizione dei consumatori.
Il dr. Dieter Schrenk, presidente del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare, ha affermato: “La nostra valutazione ha concluso che per tutte le fasce d’età della popolazione dell’UE il livello di esposizione alle nitrosammine negli alimenti desta preoccupazioni per la salute”.
Il dr Schrenk ha poi aggiunto: “Sulla base di studi sugli animali, abbiamo riscontrato l’incidenza dei tumori epatici nei roditori come l’effetto più grave sulla salute”.
“Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per la nostra valutazione dei rischi abbiamo prospettato l’ipotesi peggiore: abbiamo ipotizzato che tutte le nitrosammine presenti negli alimenti avessero lo stesso potenziale cancerogeno nell’uomo della più nociva delle nitrosammine, anche se ciò è improbabile”.
Quali sono gli alimenti che contengono nitrosammine?
Le nitrosammine sono state trovate in diversi tipi di prodotti alimentari: prodotti a base di carne, pesce lavorato, cacao, birra e altre bevande alcoliche. Il gruppo alimentare più importante che contribuisce all’esposizione alle nitrosammine è costituito dalla carne e dai prodotti a base di carne.
Le nitrosammine possono essere presenti anche in altri alimenti: le verdure trasformate, i cereali, il latte e i prodotti lattiero-caseari, o gli alimenti fermentati, sottaceto e speziati.
Attualmente ci sono alcune lacune nelle conoscenze circa la presenza di nitrosammine in specifiche categorie di alimenti. Una dieta bilanciata con la più ampia varietà possibile di alimenti potrebbe aiutare i consumatori a ridurre l’assunzione di nitrosammine.
Fonte: EFSA
 L’Assemblea dei Soci della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva è convocata il giorno 13 aprile 2023 alle ore 06.30 in prima convocazione e il giorno 13 aprile 2023 alle ore 17.00 in seconda convocazione e si svolgerà presso la sede della SIMeVeP in Via Nizza 11 a Roma, per gli adempimenti statutari e l’analisi della programmazione delle attività SIMeVeP.
L’Assemblea dei Soci della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva è convocata il giorno 13 aprile 2023 alle ore 06.30 in prima convocazione e il giorno 13 aprile 2023 alle ore 17.00 in seconda convocazione e si svolgerà presso la sede della SIMeVeP in Via Nizza 11 a Roma, per gli adempimenti statutari e l’analisi della programmazione delle attività SIMeVeP. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha avviato un progetto di ricerca denominato CONNETTI-CAT (
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha avviato un progetto di ricerca denominato CONNETTI-CAT (
 Anche quest’anno l’associazione COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes,
Anche quest’anno l’associazione COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes,  Il 24 marzo si terrà a Terni il Convegno dal titolo “PIANO DELLA PREVENZIONE 2020- 2025: obiettivi e strategie in un’ottica di one health”, patrocinato dalla SIMeVeP e a cui parteciperanno il Presidente dott. Antonio Sorice e il Presidente Onorario dott. Aldo Grasselli.
Il 24 marzo si terrà a Terni il Convegno dal titolo “PIANO DELLA PREVENZIONE 2020- 2025: obiettivi e strategie in un’ottica di one health”, patrocinato dalla SIMeVeP e a cui parteciperanno il Presidente dott. Antonio Sorice e il Presidente Onorario dott. Aldo Grasselli.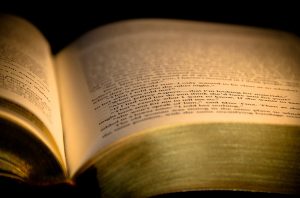 Sono online le
Sono online le  Un pesce istrice Chilomycterus reticulatus, conosciuto anche come pesce porcospino punteggiato, è l’esemplare di circa 60 cm spiaggiato a Santa Marinella e segnalato da un pescatore grazie alla campagna “
Un pesce istrice Chilomycterus reticulatus, conosciuto anche come pesce porcospino punteggiato, è l’esemplare di circa 60 cm spiaggiato a Santa Marinella e segnalato da un pescatore grazie alla campagna “ Mentre continua a suscitare grande scalpore l’inchiesta giudiziaria sull’impressionante numero di decessi avvenuti in Val Seriana durante le prime fasi della pandemia da SARS-CoV-2, credo sia utile fare alcune precisazioni.
Mentre continua a suscitare grande scalpore l’inchiesta giudiziaria sull’impressionante numero di decessi avvenuti in Val Seriana durante le prime fasi della pandemia da SARS-CoV-2, credo sia utile fare alcune precisazioni.