Linee guida per monitoraggio biotossine nelle aree di produzione e stabulazione molluschi bivalvi
 L’Ufficio 2 – Igiene degli alimenti ed esportazioni della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute ha diffuso una nota sulla pubblicazione delle Linee Guida per la valutazione del rischio per la gestione uniforme del monitoraggio delle biotossine marine nelle aree di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi a livello nazionale.
L’Ufficio 2 – Igiene degli alimenti ed esportazioni della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute ha diffuso una nota sulla pubblicazione delle Linee Guida per la valutazione del rischio per la gestione uniforme del monitoraggio delle biotossine marine nelle aree di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi a livello nazionale.
Il Regolamento (UE) 2019/627, in conformità al regolamento (UE) 2017/625, stabilisce, per i molluschi bivalvi, che nei periodi di raccolta la frequenza del campionamento ai fini dell’analisi delle tossine abbia cadenza settimanale. Tuttavia, tale frequenza può essere ridotta o aumentata in determinate zone classificate di stabulazione o di produzione o per determinati tipi di molluschi bivalvi vivi in base a una valutazione del rischio dell’Autorità Competente relativa alla presenza di tossine o fitoplancton.
Lo scopo delle Linee Guida è quindi quello di fornire un supporto alle Autorità Competenti (AC) regionali e locali per l’elaborazione della valutazione del rischio che può portare a una diminuzione o a un aumento della frequenza dei controlli.
Sul sito del Laboratorio Nazionale di Riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine (LNR-BM) Centro Ricerche Marine di Cesenatico (CRM) sono disponibili quattro documenti:
- Procedura Operativa per la Valutazione del Rischio;
- Modulo per la Valutazione del Rischio;
- Esempio di compilazione Modulo Valutazione del Rischio;
- Istruzioni Operative Monitoraggio fitoplancton tossico.
La valutazione del rischio è soggetta ad una rivalutazione periodica e deve necessariamente essere riportata in modo completo dalle AC in un documento ufficiale a giustificazione della riduzione della frequenza settimanale per il monitoraggio delle biotossine marine nei molluschi bivalvi. Questa procedura può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche ed in base all’esperienza acquisita dalle stesse AC dall’applicazione dei Regolamenti Comunitari.
Per approfondire consulta la pagina dedicata del sito del Laboratorio Nazionale di Riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine (LNR-BM) Centro Ricerche Marine di Cesenatico
-
Istruzioni Operative Monitoraggio fitoplancton tossico (rev. del 09/05/2023)
-
Procedura Operativa per la Valutazione del Rischio (rev. del 19/06/2023)
-
Modulo per la Valutazione del Rischio (rev. del 15/05/2023)
-
Esempio di compilazione Modulo Valutazione del Rischio (rev.0 del 15/05/2023)
- Fonte: ceirsa.org
 A febbraio 2023 la sezione Sicurezza Alimentare del CNSA (Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare, ha emesso il documento tecnico “
A febbraio 2023 la sezione Sicurezza Alimentare del CNSA (Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare, ha emesso il documento tecnico “ Il 20 settembre 2022 è stato pubblicato il nuovo
Il 20 settembre 2022 è stato pubblicato il nuovo  Il Rapporto “Clima in Italia nel 2022”, pubblicato dall’ISPRA con cadenza annuale dal 2006, quest’anno diventa un prodotto SNPA. Grazie al coinvolgimento del Sistema nazionale per la protezione ambientale, si arricchisce di approfondimenti sul clima anche a scala regionale e locale, nonché su aspetti idro-meteo-climatici e meteo-marini più rilevanti dell’anno in esame.
Il Rapporto “Clima in Italia nel 2022”, pubblicato dall’ISPRA con cadenza annuale dal 2006, quest’anno diventa un prodotto SNPA. Grazie al coinvolgimento del Sistema nazionale per la protezione ambientale, si arricchisce di approfondimenti sul clima anche a scala regionale e locale, nonché su aspetti idro-meteo-climatici e meteo-marini più rilevanti dell’anno in esame.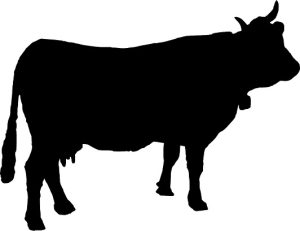 In relazione al caso di intossicazione acuta in un gruppo di bovini e la conseguente moria di 13 animali avvenute nel comune di Gambugliano (Vicenza), e a seguito degli accertamenti diagnostici, i veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e dell’Ulss 8 Berica ritengono che la causa sia da imputare all’ingestione di sorgo selvatico.
In relazione al caso di intossicazione acuta in un gruppo di bovini e la conseguente moria di 13 animali avvenute nel comune di Gambugliano (Vicenza), e a seguito degli accertamenti diagnostici, i veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e dell’Ulss 8 Berica ritengono che la causa sia da imputare all’ingestione di sorgo selvatico. Il 27 luglio il Presidente, dott. Antonio Sorice parteciperà alla presentazione del XII rapporto nazionale di Legambiente “Animali in città”.
Il 27 luglio il Presidente, dott. Antonio Sorice parteciperà alla presentazione del XII rapporto nazionale di Legambiente “Animali in città”.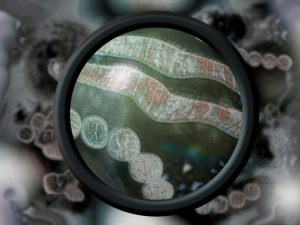 Il virus dell’
Il virus dell’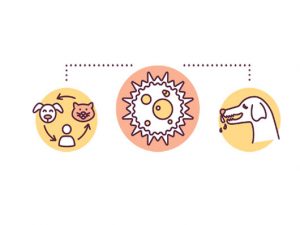 Anticorpi al virus H5N1 in 5 cani e un gatto in un allevamento del Bresciano. Per gli esperti, più che una sorpresa è la conferma che il virus ad alta patogenicità, responsabile della grande epidemia di aviaria diffusa a livello globale, può essere trasmesso dai volatili ai mammiferi e, quindi, all’uomo.
Anticorpi al virus H5N1 in 5 cani e un gatto in un allevamento del Bresciano. Per gli esperti, più che una sorpresa è la conferma che il virus ad alta patogenicità, responsabile della grande epidemia di aviaria diffusa a livello globale, può essere trasmesso dai volatili ai mammiferi e, quindi, all’uomo. Sistemi alimentari sostenibili
Sistemi alimentari sostenibili Primo caso confermato di infezione da virus West Nile (WNV) nell’uomo dall’inizio della sorveglianza, segnalato in un donatore di sangue nella Provincia di Parma (Provincia già colpita dalla circolazione del virus negli animali vettori). Inoltre, salgono a 14 le Province con dimostrata circolazione di WNV in vettori e animali, appartenenti a 5 Regioni: Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna, Sicilia e Sardegna.
Primo caso confermato di infezione da virus West Nile (WNV) nell’uomo dall’inizio della sorveglianza, segnalato in un donatore di sangue nella Provincia di Parma (Provincia già colpita dalla circolazione del virus negli animali vettori). Inoltre, salgono a 14 le Province con dimostrata circolazione di WNV in vettori e animali, appartenenti a 5 Regioni: Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna, Sicilia e Sardegna.