Malattia X da causa X in Congo, la storia si ripete!
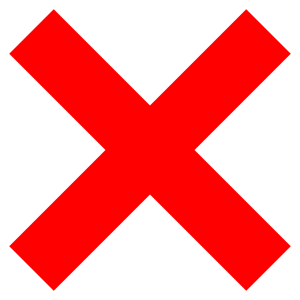 La “nuova” malattia insorta nella Repubblica Democratica del Congo, già messa a dura prova dall’epidemia di “Monkeypox”, avrebbe sin qui provocato almeno 450 casi e oltre 30 decessi, soprattutto fra i bambini al di sotto dei 5 anni.
La “nuova” malattia insorta nella Repubblica Democratica del Congo, già messa a dura prova dall’epidemia di “Monkeypox”, avrebbe sin qui provocato almeno 450 casi e oltre 30 decessi, soprattutto fra i bambini al di sotto dei 5 anni.
A dispetto della recentissima notizia relativa alla presenza di una “coinfezione” da Plasmodium falciparum/vivax/malariae – agenti della malaria, malattia endemica nel Continente Africano – nell’80% dei pazienti colpiti dalla “nuova” malattia congolese, fattispecie quest’ultima che renderebbe oltremodo di plausibile e giustificata la frequente coesistenza di quadri anemici negli stessi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le più importanti Istituzioni planetarie coinvolte nella lotta, nel controllo e nella profilassi delle malattie infettive (quali i prestigiosi “Centers for Disease Control and Prevention”/CDC di Atlanta, negli USA) brancolano ancora nel buio.
A tal proposito, infatti, andrebbe parimenti sottolineato che i succitati quadri anemici si rinvenirebbero comunemente associati ad altre manifestazioni cliniche comprendenti tosse, disturbi respiratori, cefalea ed ipertermia febbrile, elementi dai quali trarrebbe sostegno l’ipotesi di un coinvolgimento di uno o più patogeni respiratori, ai quali potrebbe essere altresì ascritto il ruolo di agente/agenti primario/primari.
Mutatis mutandis, ben prima che il virus responsabile dell’AIDS (Human Immunodeficiency Virus/HIV) venisse contemporaneamente e definitivamente identificato da Luc Montagnier (in Francia) e da Robert Gallo (in USA) nel lontano 1983, i sospetti iniziali si erano indirizzati, per oltre due anni, su Pneumocystis carinii (successivamente ribattezzato P. jirovecii), un protozoo di frequente riscontro nei pazienti affetti da AIDS e che “col senno di poi” avrebbe rappresentato la “punta dell’iceberg” dell’infezione da HIV, costituendo al tempo stesso uno degli svariati agenti opportunisti responsabili di infezioni secondarie in tali individui.
In effetti, si potrebbero citare molteplici esempi di infezioni secondarie sostenute da protozoi sia in persone che in animali primariamente infetti ad opera di agenti immunodeprimenti/immunodepressivi, virali e non, quali Toxoplasma gondii sempre in pazienti con AIDS nonché in cani affetti da cimurro (malattia causata da “Canine Distemper Virus”/CDV, un Morbillivirus) e in delfini con infezione da “Cetacean Morbillivirus” (CeMV, un altro Morbillivirus).
E, poiché di agenti protozoari anche nel caso di Plasmodium falciparum, P. vivax e P. malariae si tratta, l’ipotesi di un coinvolgimento secondario degli stessi nell’eziologia della misteriosa malattia congolese potrebbe risultare plausibile, tanto più in ragione del fatto che i disturbi respiratori osservati nei bambini affetti da siffatta “sindrome X” non rientrerebbero fra i reperti clinico-sintomatologici tipici della malaria.
Se poi andiamo a scavare, neppure più di tanto, nell’affascinante storia delle malattie infettive, fatto salvo il succitato eloquente esempio dell’AIDS, ci accorgiamo che l’identificazione di SARS-CoV, il betacoronavirus responsabile della SARS – malattia riconosciuta per la prima volta nel 2002 dal medico italiano Carlo Urbani, poi deceduto a causa della stessa – è stata preceduta dall’attribuzione, ad opera di ricercatori cinesi, di una responsabilità causale non gia’ ad un agente virale, ma bensi’ a batteri del genere Chlamydia.
Nel mondo animale poi, tanto per citare un ulteriore, eloquente esempio, prima che si addivenisse alla scoperta di una serie di nuovi membri del genere Morbillivirus quali responsabili di devastanti epidemie fra i mammiferi marini (Pinnipedi e Cetacei), la cui salute e conservazione appaiono sempre più minacciate per mano dell’uomo, altri agenti erano stati indiziati quali noxae causali, primo fra tutti Herpesvirus, rivelatosi in seguito un patogeno frequentemente coinvolto in infezioni secondarie. Illuminanti esempi di questo tipo non mancano neppure tra gli ospiti animali invertebrati, come chiaramente ci mostrano i ripetuti episodi di mortalità collettiva che in anni recenti hanno interessato le popolazioni di nacchere (Pinna nobilis) in più aree del Mediterraneo. Si tratta del più grande mollusco bivalve lamellibranco presente nella regione, i cui eventi di mortalità collettiva erano stati ricondotti all’azione di un protozoo (Haplosporidium pinnae) e di batteri (Mycobacterium sherrisii, Vibrio mediterranei) prima che si addivenisse a definirne l’eziologia primaria, ascrivibile ad un piccolo virus a RNA facente parte dell’ordine Picornavirales, rispetto al quale il parassita e i due batteri anzidetti andrebbero considerati come agenti opportunisti d’irruzione secondaria.
Alla luce di quanto sopra, verrebbe da dire che la “malattia X” recentemente identificata in Congo non rappresenti un’eccezione alla regola secondo cui l’identificazione certa di qualsivoglia agente causale di qualsivoglia nuova malattia infettiva (e non) sia anticipata, giocoforza, da “errori” grazie ai quali l’accertamento della responsabilità eziologica primaria emergera’ a tempo debito e a coronamento degli sforzi profusi dalla Comunità Scientifica, in una sana ottica di collaborazione intersettoriale e multidisciplinare e, nondimeno, nel segno della “One Health”, la salute unica di uomo, animali ed ambiente.
Historia Magistra Vitae!
Giovanni Di Guardo,
DVM, Dipl. ECVP,
Già Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo
 La SIMeVeP in collaborazione con ADMV, Associazione Donne Medico Veterinario, ha organizzato per il 18 dicembre il Webinar dal titolo “Focus sull’uso del farmaco negli animali d’affezione” tenuto dalla dottoressa Silvia Fiorina e dal dottor Marco Cecchetto del
La SIMeVeP in collaborazione con ADMV, Associazione Donne Medico Veterinario, ha organizzato per il 18 dicembre il Webinar dal titolo “Focus sull’uso del farmaco negli animali d’affezione” tenuto dalla dottoressa Silvia Fiorina e dal dottor Marco Cecchetto del  L’EFSA in un rapporto scientifico del 4 Dicembre 2024 dal titolo ‘Fattori di rischio e di protezione per la Peste suina africana nei suini domestici e nei cinghiali nell’UE e misure di mitigazione per la gestione della malattia nei cinghiali’, utilizzando revisioni delle pubblicazioni scientifiche, studi sul campo, questionari e modelli matematici, individua e valuta cinque aspetti epidemiologici della PSA.
L’EFSA in un rapporto scientifico del 4 Dicembre 2024 dal titolo ‘Fattori di rischio e di protezione per la Peste suina africana nei suini domestici e nei cinghiali nell’UE e misure di mitigazione per la gestione della malattia nei cinghiali’, utilizzando revisioni delle pubblicazioni scientifiche, studi sul campo, questionari e modelli matematici, individua e valuta cinque aspetti epidemiologici della PSA. In Europa vivono sei specie di grandi carnivori: orso, lupo, lince eurasiatica, lince iberica, ghiottone e sciacallo dorato. La maggior parte delle popolazioni di questi predatori ha mostrato negli ultimi sei anni un complessivo trend di crescita sia numerica che di distribuzione, come dimostra
In Europa vivono sei specie di grandi carnivori: orso, lupo, lince eurasiatica, lince iberica, ghiottone e sciacallo dorato. La maggior parte delle popolazioni di questi predatori ha mostrato negli ultimi sei anni un complessivo trend di crescita sia numerica che di distribuzione, come dimostra  La presente relazione presenta i risultati della sorveglianza sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini, nei caprini, nei cervidi e in altre specie e della genotipizzazione negli ovini e nei caprini, effettuata nel 2023 da 27 Stati membri (SM, UE-27), dal Regno Unito (rispetto all’Irlanda del Nord (XI)) e da altri otto paesi dichiaranti non appartenenti all’UE: Bosnia-Erzegovina, Islanda, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Svizzera (i dati comunicati dalla Svizzera comprendono quelli del Liechtenstein) e Turchia.
La presente relazione presenta i risultati della sorveglianza sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini, nei caprini, nei cervidi e in altre specie e della genotipizzazione negli ovini e nei caprini, effettuata nel 2023 da 27 Stati membri (SM, UE-27), dal Regno Unito (rispetto all’Irlanda del Nord (XI)) e da altri otto paesi dichiaranti non appartenenti all’UE: Bosnia-Erzegovina, Islanda, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Svizzera (i dati comunicati dalla Svizzera comprendono quelli del Liechtenstein) e Turchia.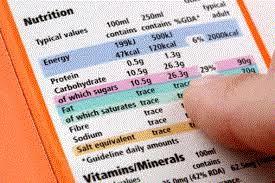 I consumatori possono facilmente perdersi in un labirinto di etichette degli alimenti, avverte la Corte dei conti europea in una relazione pubblicata in data odierna. L’etichettatura degli alimenti dovrebbe aiutare le persone a prendere decisioni consapevoli al momento dell’acquisto. I consumatori dell’UE sono però esposti ad un numero crescente di indicazioni, loghi, slogan, etichette e punteggi che possono non solo creare confusione, ma anche risultare fuorvianti.
I consumatori possono facilmente perdersi in un labirinto di etichette degli alimenti, avverte la Corte dei conti europea in una relazione pubblicata in data odierna. L’etichettatura degli alimenti dovrebbe aiutare le persone a prendere decisioni consapevoli al momento dell’acquisto. I consumatori dell’UE sono però esposti ad un numero crescente di indicazioni, loghi, slogan, etichette e punteggi che possono non solo creare confusione, ma anche risultare fuorvianti. Vent’anni fa un articolo apparso su
Vent’anni fa un articolo apparso su  Un nuovo studio condotto dall’
Un nuovo studio condotto dall’ La salute degli esseri umani, degli animali e degli ecosistemi non può essere considerata come un insieme di realtà separate, ma emerge, come già osservato da tempo, da un’interdipendenza intrinseca. In un mondo che si fa sempre più interconnesso, non può più esistere una scienza separata dalle altre: diventa imprescindibile un dialogo tra i saperi. È in questa prospettiva che si colloca il concetto di One Health, una visione olistica e integrata della salute che riconosce l’unità del vivente e la necessità di una collaborazione interdisciplinare per affrontare le sfide del nostro tempo.
La salute degli esseri umani, degli animali e degli ecosistemi non può essere considerata come un insieme di realtà separate, ma emerge, come già osservato da tempo, da un’interdipendenza intrinseca. In un mondo che si fa sempre più interconnesso, non può più esistere una scienza separata dalle altre: diventa imprescindibile un dialogo tra i saperi. È in questa prospettiva che si colloca il concetto di One Health, una visione olistica e integrata della salute che riconosce l’unità del vivente e la necessità di una collaborazione interdisciplinare per affrontare le sfide del nostro tempo. Dieci sedi centrali e 90 sezioni diagnostiche periferiche, oltre 5mila collaboratori tra ricercatori veterinari, chimici, biologi, agronomi, tecnologi alimentari, tecnici di laboratorio biomedico, ingegneri, statistici e personale amministrativo, una media di 25 milioni di analisi di laboratorio effettuate annualmente. Questi sono i numeri presentati dalla Rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali Italiani (IIZZSS) alla 19° edizione del “Forum risk management” in corso ad Arezzo. L’evento si pone l’ambizioso obiettivo di parlare della “sanità di domani” con dibattiti e confronti finalizzati al rilancio e alla riforma del sistema sanitario.
Dieci sedi centrali e 90 sezioni diagnostiche periferiche, oltre 5mila collaboratori tra ricercatori veterinari, chimici, biologi, agronomi, tecnologi alimentari, tecnici di laboratorio biomedico, ingegneri, statistici e personale amministrativo, una media di 25 milioni di analisi di laboratorio effettuate annualmente. Questi sono i numeri presentati dalla Rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali Italiani (IIZZSS) alla 19° edizione del “Forum risk management” in corso ad Arezzo. L’evento si pone l’ambizioso obiettivo di parlare della “sanità di domani” con dibattiti e confronti finalizzati al rilancio e alla riforma del sistema sanitario.